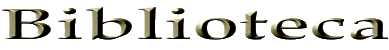Albrecht Dürer. Autoritratto
Buccleuch. Iconologia e iconografia. Indagine e
ricerca (Attorno all'arte, 16), Cagli. ISBN
9788876582240.

Questa mia nuova ricerca ha comportato una serie
di indagini per verificare l’autenticità
dell’opera di mano di Albrecht Dürer sia
attraverso i documenti che mi sono stati
consegnati sia i dati riportati dalle fonti per
determinare il periodo dell’opera, controllare
le analisi pregresse, il suo restauro, comparare
i particolari e definire l’artista.
L’Autoritratto Buccleuch è stato così definito,
in quanto appartenente alla collezione scozzese
del 5° Duca di Buccleuch, in base alla
identificazione di una etichetta posta nel retro
del quadro con la data “Buccleuch/July 23
[18]89” è un’opera di cui abbiamo le prime
notizie, da parte di Giorgio Vasari, nelle sue
edizioni a stampa, che si differenzia da l’altro
autoritratto che è su tavola ed a Monaco.
Chi
conosce bene gli scritti del Vasari sulla vita
di Raffaello saprà bene che vi è scritto così:
"gli mandò la testa d'un suo ritratto condotta
da lui a guazzo su una tela di bisso, che da
ogni banda mostrava parimente e senza biacca i
lumi trasparenti, se non che con acquerelli di
colori era tinta e macchiata, e de' lumi del
panno aveva campato i chiari, la quale cosa
parve maravigliosa a Raffaello."
E nella vita
di Giulio Romano: "Fra le molte cose rare che
aveva in casa sua, vi era in una tela di rensa
sottile il ritratto naturale d'Alberto Duro di
mano di esso Alberto, che lo mandò come altrove
si è detto, a donare a Raffaello da Urbino. Il
qual ritratto era cosa rara perché, essendo
colorito a guazzo con molta diligenza e fatto
d'acquarelli, l'aveva finito Alberto senza
adoperare biacca, et in quel cambio si era
servito del bianco della tela, delle fila della
quale, sottilissime, aveva tanto ben fatti i
peli della barba, che era cosa da non potersi
imaginare, non che fare, et al lume traspareva
da ogni lato."
La traduzione in sintesi del
testo del Vasari è che era stata fatta a guazzo
(misto colori ad olio e acqua) su tela di bisso,
la tela di cui è fatta quella del nostro
autoritratto. La tela di bisso o lino fine è il
materiale che è stato riscontrato nelle analisi
e nel restauro.
Raffaello dona dei disegni a
Durer tra cui uno è documentato:
L'uomo
all'estrema destra fa un passo in avanti con la
gamba sinistra, la gamba destra indietro e
posiziona il braccio sinistro mentre indica
qualcosa in lontananza con il braccio destro. A
destra di questa figura sulla pagina del disegno
c'è un'iscrizione in tedesco scritta da Albert
Durer e datata 1515: 1515 Raphahill de Urbin,
der so hoch peim Pobst geacht ist gewest hat der
hat dyse nackette Bild gemacht und hat sy dem
Albrecht Dürer gen Nornberg geschickt, Im sein
hand zu weisen. Traduzione: '1515 Raffaello di
Urbino, che è così apprezzato dal Papa, afferma
di aver realizzato questo disegno nudo e di
averlo inviato ad Albrecht Dürer a Nornberg
[per] mostrargli / dimostrargli la sua mano” Un
disegno preparatorio documentato di uomini di
Raffaello inviato a Durer. La figura di estrema
destra di Raffaello nel disegno viene quindi
vestita dall'artista e dipinta nella scena
all'estrema sinistra del suo affresco La
battaglia di Ostia (1514-1517) nelle Stanze
Vaticane.
Ho affrontato questo tema viste le
dichiarazioni attraverso le quali è stato
possibile determinare il percorso dell’opera e
la sua sparizione poi in seguito per secoli ed
infine ritrovata nel mercato del collezionismo
privato: Raffaello Santi; Giulio Romano;
Raffaello figlio di Giulio Romano; Jacopo Strada
antiquario; Disperso; Henry Farrar; John Heugh
di Glasgow; 5° Duca di Buccleuch, castello di
Drumlanring; antiquariato; attuale proprietario.
Altra indagine e verifiche, da parte mia, sono
state fatte sulle analisi effettuate con le
radiografie presso l’Istituto de la “Lumiere
Technology” di Parigi e sulle analisi fatte a
Zurigo presso il laboratorio tecnico-scientifico
di microanalisi del prof. Dr. Elisabeth Jagers e
del Dr. Erhard Jagers.
Le analisi:
ETH -
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich,
Swiss Federal Institute of Technology Zürich:
“…L'immagine mostra un ritratto di un uomo con i
capelli lunghi. Indossa un indumento con collo
di pelliccia. A sinistra della sua testa si vede
un'iscrizione gialla. Il dipinto non è firmato.
È attribuito ad Albrecht Dürer. Il tempo di
origine stimato è di circa 1500 anni.
…Il
supporto è in tela di lino molto fine. La tela
originale è raddoppiata con teli nuovi. I bordi
originali sono parzialmente persi. Le tele sono
fissate su un asse di sambuco in una struttura a
croce centrale. Sulla struttura di legno sono
visibili alcuni vecchi adesivi e numeri. Il
dipinto ha un fondo bianco grigiastro.
La
vernice è un colore a olio stabile. Nella
maggior parte dei casi viene applicato in modo
sottile. Parti leggermente pastose possono
essere viste nelle parti bianche. Le tracce del
pennello sono evidenti a volte. La vernice viene
applicata bagnata su bagnato [tempera], in modo
che i colori finali vengano miscelati sulla
tela.
Alla luce UV si possono vedere alcuni
ritocchi o vernici eccessive. Alcuni vecchi
ritocchi possono essere stati oscurati solo in
modo oscuro.
Gli strati di vernice mostrano
un craquelé con invecchiamento omogeneo. In
alcune parti si possono osservare rotture
causate meccanicamente e grossolanamente.
Tutti i materiali identificati erano materiali
di artisti ben utilizzati negli anni di circa
1500 leganti è, secondo i suoi dati
spettroscopici, ben polimerizzato e
uniformemente invecchiato.
Soprattutto
l'identificazione del giallo pigmento piombo
stagno giallo, che non è mai stata identificata
in dipinti con una data di origine successiva al
1700 è un argomento per il fatto che si tratta
di un vecchio dipinto. L'iscrizione gialla sul
lato frontale mostra lo stesso pigmento.
Pertanto, i risultati degli esami sui materiali
pittorici non sono in contraddizione con
l'attribuzione del dipinto ad Albrecht Dürer.”.
Radiografie presso l’Istituto de la “Lumiere
Technology” di Parigi:
“Le radiografie
rilevano la omogeneità dell’opera nei primi del
1500 e non fatta con materiali postumi.”
Il
restauro dell’opera è stato eseguito dalla
dott.ssa Sara Penco di Roma ed ha rilevato la
tecnica, la tela di bisso ed il periodo nel
1500.
Note del restauro, riporto solo alcune
parti:
“Il dipinto misura cm. 63 x cm. 49 e
raffigura l’effige di Albert Dürer.
Il ritratto è
facilmente riconducibile alla famosa tavola
conservata presso l’Alte Pinakothek di Monaco di
Baviera. Malgrado il fatto che la tela in
restauro replichi fedelmente il famoso dipinto
di Monaco, ad un osservatore attento non possono
sfuggire alcune singolari caratteristiche che
impongono altrettante non trascurabili
riflessioni.
Il primo quesito è il seguente:
perché un copista avrebbe replicato fedelmente
il ritratto su tavola di Monaco, usando una tela
anziché il consueto supporto ligneo
caratteristico della manifattura fiamminga?
Proprio l’inusuale supporto usato per dipingere
il ritratto (una tela sottile e pregiata) e la
straordinaria quanto evidente qualità pittorica
del dipinto in restauro, hanno reso
indispensabile intraprendere un’accurata ed
approfondita indagine preliminare, da anteporre
all’intervento di restauro.
Una prima
osservazione dell’opera d’arte ha permesso di
stabilire che il dipinto era già stato
sottoposto ad almeno un precedente intervento di
restauro, durante il quale la tela è stata
rifoderata.
In concomitanza con l’intervento
di rifodero, l’originale telaio fisso è stato
sostituito con uno mobile e più idoneo alla
conservazione del dipinto, perché più adatto ad
assecondare i naturali “assestamenti” dei
diversi materiali che compongono l’opera d’arte.
Queste considerazioni mi hanno indotta ad
ipotizzare la presenza di ridipinture molto più
invasive di quanto si potesse immaginare
attraverso una prima indagine.
…La pellicola
pittorica originale suggeriva una datazione
riconducibile al XVI secolo, mentre le
caratteristiche pittoriche del fondo del dipinto
inducevano in inganno ai fini della corretta
identificazione del periodo storico di
appartenenza del manufatto: tanto che era quasi
legittimo indurre l’osservatore poco attento a
collocarlo in un periodo storico identificabile
tra il XVIII ed il XIX secolo.
Tuttavia, ero
convinta che la materia pittorica originale
confermasse che il dipinto era molto più antico.
Escludevo, dunque, una datazione riconducibile
ai primi anni del XVI secolo.
L’indagine
preliminare aveva evidenziato la probabilità che
tutto il fondo del manufatto fosse stato
completamente manomesso nel corso di un datato
intervento di restauro.
A conferma di questa
ipotesi notavo che i contorni della figura,
soprattutto in prossimità di alcuni riccioli che
sarebbero dovuti terminare sovrapponendosi allo
sfondo, si presentavano troppo “scontornati” e
che il verde era decisamente più “scadente”
rispetto alla elevata qualità del resto della
pittura (sia come pigmento che come
pennellata).”.
Ho rintracciato altre
pubblicazioni storiche che citano questa opera
perché si differenzia come “tela di bisso”
dall’altra su “tavola” di cui non abbiamo mai
una illustrazione facendo sempre riferimento
come “Autoritratto con pelliccia di Albrecht
Dürer”.
In base a questi riferimenti
preciserò che la prima opera fu quella su tela e
dopo che Raffaello la ebbe in dono e mandò un
suo disegno nel 1515 – come in seguito vedremo -
in cambio del favore, il nostro Dürer la rifece
per sé su tavola.
Essendo iniziate le
celebrazioni dei 500 anni della morte di
Raffaello (Urbino, 28 marzo 1483 – Roma, 6
aprile 1520) voglio dedicare ai due famosi
artisti questa pubblicazione, una delle più
importanti dell’artista tedesco definito da
molti “il Leonardo tedesco”.
Nella
pubblicazione ho sviluppato il rapporto
dell’Autoritratto del Dürer dove il suo viso
riprende il “volto di Cristo” della sacra
Sindone, il “volto di Cristo” nel velo della
Santa Veronica ed il “volto di Cristo” di
Manoppello.
Punto centrale è il Volto di
Cristo.
Il rapporto tra le sacre
rappresentazioni è il tema centrale
dell’Autoritratto del Dürer. La Sindone o il
Velo di Cristo di Manoppello, o la stessa
rappresentazione fin dai primi mosaici del IV
sec. sono ripresi come esempio di continuità da
parte degli artisti.
Anno 1500- 1502
avvengono due importanti fatti: l’ottavo
Giubileo indetto da Alessandro VI e la
costruzione nel 1502 a Chambéry da parte dei
Savoia nella loro capitale una cappella apposita
per conservare la Sindone.
Per i Giubileo:
L'ottavo Giubileo fu indetto il 28 marzo 1499 da
papa Alessandro VI della famiglia dei Borgia,
grazie alla bolla Inter multiplices. Ad
Alessandro VI si deve il rito di aprire e
chiudere il Giubileo con l'apertura e la
chiusura della Porta Santa. Inoltre, il Papa
volle che Porte Sante delle quattro basiliche
fossero aperte contemporaneamente, riservando a
sé l'apertura della Porta Santa di San Pietro.
Il liturgista e cerimoniere pontificio Giovanni
Burcardo preparò un apposito cerimoniale; così
la Vigilia di Natale 1499, Alessandro VI
personalmente colpiva con alcuni colpi di
martello il muro della Porta Santa e poi, in
ginocchio, ne varcava la soglia per primo il 13
aprile 1500. Lo stesso Papa guidò una
processione penitenziale.
Fu Papa Alessandro
VI, nel 1502, su richiesta dei Savoia, a
stabilire il giorno 4 maggio come festa
liturgica per il riconoscimento della Sindone.
Per la Sindone: All'incirca nel 1415 il conte
Umberto de la Roche, marito di Margherita di
Charny, figlia di Goffredo II, prende in
consegna il lenzuolo per metterlo al sicuro in
occasione della guerra tra la Borgogna e la
Francia. Margherita si rifiuta poi di
restituirlo alla collegiata di Lirey
reclamandone la proprietà. I canonici la
denunciano, ma la causa si protrae per molti
anni e Margherita comincia a organizzare una
serie di ostensioni nei viaggi in giro per
l'Europa (intanto Umberto muore nel 1448). Nel
1449 a Chimay, in Belgio, dopo una di queste
ostensioni il vescovo locale ordina
un'inchiesta, a seguito della quale Margherita
deve mostrare le bolle papali in cui il telo
viene definito una raffigurazione e come
conseguenza l'ostensione venne interrotta e lei
venne espulsa dalla città. Negli anni successivi
continua a rifiutare di restituire la Sindone
finché, nel 1453, la vende ai duchi di Savoia.
Successivamente, nel 1457, a causa di questi
suoi comportamenti viene scomunicata.
I
Savoia conservano la Sindone nella loro
capitale, Chambéry, dove nel 1502 fanno
costruire una cappella apposita; nel 1506
ottengono da Giulio II l'autorizzazione al culto
pubblico della Sindone con messa e ufficio
proprio.
Dürer, Raffaello, Leonardo da Vinci
conoscevano bene la esposizione della Sindone a
Chambéry.
Raffaello ha voluto il ritratto di
Dürer, e Leonardo ha fatto il Salvator Mundi. Al
centro il volto di Cristo.
Nella
pubblicazione Albrecht Dürer. Autoritratto
Buccleuch. Iconologia e iconografia. Indagine e
ricerca in qualità sia di editore che di
scrittore ho voluto far omaggio inserendo
un’opera pittorica disegnata con pastello
morbido tutto colore della pittrice riminese
Denise Camporesi.
Perché ho scelto la
Camporesi? Ultimamente l’artista ha dipinto
sette grandi opere denominate “Molecole
d’Angeli” di cui tre saranno esposte
permanentemente nell’Ala Nuova dell’Ospedale di
Rimini. Essendo il curatore per organizzare una
mostra personale a Roma sugli Angeli e Ritratti
fatti dalla Camporesi, ho voluto che mi
rappresentasse una immagine legata a quanto ho
scritto sull’Autoritratto del Dürer, donato a
Raffaello Santi, e il Volto di Cristo.
L’opera della Denise affascina per il
collegamento con le antiche rappresentazioni:
“Angioletto con il Velo di Cristo o volto della
Sindone” come la Santa Veronica (la cui
traduzione dal greco è Vera Icona) dove le
sfumature colorate, gli occhi dolci e teneri, le
manine che sorreggono il velo trasparente con il
volto della Sindone, i piedini sorretti dalle
nuvole, fanno di questo un capolavoro da
ricordare affiancandolo alle opere di grandi
artisti.
L’ispirazione della Camporesi deriva
nel rappresentare in forma moderna un angioletto
antico che sorregge un telo finissimo o telo di
bisso marino lavorato dove è impressa l’immagine
del volto di Cristo così come fu rilevato dalle
analisi radiografiche a Torino, dove è
conservato.
Questo 2020 è l’anno che si
ricorderanno sia i 500 anni dalla morte di
Raffaello, ma anche personaggi come Leonardo da
Vinci con il suo Salvator Mundi e Dürer con il
suo Autoritratto come fulcro centrale legato al
volto ed il corpo di Cristo. Lo stesso Salvator
Mundi rappresenta il viso del Cristo come detto
sopra anche per Dürer.
Il rapporto tra le
sacre rappresentazioni e la Sindone è il tema
centrale dell’Autoritratto del Dürer. La Sindone
o il Velo di Cristo di Manoppello, o la stessa
rappresentazione fin dai primi mosaici del IV
sec. sono ripresi come esempio di continuità da
parte degli artisti fino a Denise Camporesi.
Questo 2020 è l’anno che si ricorderanno sia i
500 anni dalla morte di Raffaello, ma anche
personaggi come Leonardo da Vinci con il suo
Salvator Mundi e Dürer con il suo Autoritratto
come fulcro centrale legato al volto ed il corpo
di Cristo.
Biblioteche lettura del testo: