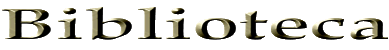In questo
ultimo ventennio una miriade di microstudi
stanno alimentando lo sviluppo per la
scrittura di una nuova storia, in alcuni casi
ancora troppo legata ad interessi localistici
ed in altri innovativa, ma per la maggior
parte delle volte assente e troppo elaborata
per il vasto pubblico che ha sete di sapere.
Importanti edizioni universitarie ed
artistiche pubblicazioni sponsorizzate da
banche ed enti il più delle volte sono
sconosciute agli studiosi, se non divulgate
nei giusti canali bibliografici.
A
questo si aggiunga che archivi ecclesiastici,
fondi comunali, biblioteche ed archivi privati
rappresentano l’altro settore che non potendo
essere consultato crea dei vuoti nella
conoscenza e nel caso in cui questo non
avvenga, la maggior parte delle volte molti
autori plagiano, quanto già è stato scritto,
ma non pubblicato o addirittura trascrivono
male testi greci e latini.
Un importante
ed antico fondo di documenti imperniato sulle
attività nei secoli degli abitanti di
Paravento e di Frontone per lavorare le
risorse offerte dal Monte Catria e dall’Acuto
è stato da me scoperto nell’archivio storico
della Chiesa e scomparsa Abbadia di S. Michele
Arcangelo di Paravento. La storia della
Abbadia era già stata tracciata da alcuni
parroci e le controversie per il diritto al
pascolo ed al taglio della legna erano state
raccolte in migliaia di fogli sciolti che
rappresentano i contratti, le testimonianze,
le affide, gli impegni economici utili alla
ricostruzione di una prima definizione dei
confini che nei secoli hanno diviso questi
territori. La lettura dei toponimi scomparsi
mi hanno dato un importante sostegno per
delineare le antiche strade, quelle strade che
già più di duemila anni fa erano percorse
dagli uomini di Frontone per sopravvivere
lavorando la terra, allevando il bestiame e
tagliando la legna dei boschi. Tutto questo
grazie al Catria ed all’Acuto che hanno avuto
una primaria funzione sacrale per gli Umbri ed
i Romani e per quei monaci prima benedettini,
poi avellaniti che nel periodo cristiano sono
stati missionari per la divulgazione della
parola di Cristo.
La storia di Frontone vive nei quattro
elementi che danno vita alla vita: terra,
aria, acqua, fuoco,.
La Montagna è terra bagnata dalle acque dei
ruscelli che generano quanto occorra al
sostentamento primario e nella quale nascono i
boschi e la vegetazione, che producono l’aria
che respiriamo e con il loro taglio alimentano
il fuoco, produttore di vapore che rigenera
acqua.
Una dedica speciale vorrei farla al fratello
di mio nonno Ernesto Paleani, Don Giovanni che
con la sua dedizione fu il Pievano della
chiesa di S. Savino dal 1890 al 1917, e in
questo luogo nell’antichità era stato fondato
un insediamento Umbro nel vocabolo
Trebbio
e dal quale si risaliva per la via sacra verso
l’ara di Frontone, dove il Frontac - il
sacerdote che interpreta i fulmini - dava i
suoi responsi traendo le sue divinazioni dal
Catria.
Un ringraziamento per aver avuto l’occasione
di consultare il fondo parrocchiale di S.
Maria Assunta di Frontone a Don Ferdinando
Radicchi; un saluto cordiale a Mario Bocchi
che con la sua amicizia da oltre dieci anni
scambiamo le nostre opinioni su l’Abbate
Frontone, di cui nulla si sa di preciso e di
cui una valida ricerca è stata improntata
dallo stesso Bocchi; un ringraziamento a Don
Gabriele, parroco della pieve di S. Stefano di
Acquaviva e S. Michele Arcangelo di Paravento,
che mi ha permesso di in-ventariare e
consultare l’archivio parrocchiale
comprendente il fondo antico dell’Abbadia e il
fondo relativo ai rapporti degli Uomini di
Paravento e di Frontone in causa con il
Collegio Germanico di Roma e la Badia di S.
Croce di Fonte Avellana relativamente ai
diritti di uso della Montagna del Catria e
dell’Acuto.
Questa pubblicazione rientra nella serie dei
volumi che commentano il tracciato che veniva
percorso da Cagli fino a Sassoferrato, nella
parte della Montagna opposta al percorso della
strada consolare Flaminia.
Il Catria, gli itinerari e le confinazioni
antiche saranno l’argomento generale,
lumeggiato dalla vecchie e nuove scoperte
archeologiche in un ambiente millenario
circondato da luoghi di culto pagani e
cristiani.
Frontone verrà esaminata nei minimi
particolari archeologici in base alla
restituzione di reperti che vanno dal XII sec.
a. C. fino al II d.C. inquadrando l’area a
confine tra l’attuale Umbria e Marche; in
questo ambito viene creata una ipotetica
pianta di percorsi tracciando le prime vie di
transumanza nel periodo preromano o paleumbro
(collegamento tra le valli del Cesano, Cinisco
con il Catria e la valle del Candigliano e
Metauro con il Nerone) fino a delineare i
percorsi nel periodo romano, la
Via sacra longobardorum
per giungere nel
Gargano al Santuario di S. Michele Arcangelo e
nel basso medioevo la strada di
Corgnaletum
che congiungeva Cagli con Serra S. Abbondio.
Delineate le strade verranno stabiliti i
confini del
Castrum Frontoni
e del suo luogo di culto dedicato alla S.
Maria Assunta nel succedersi di varie epoche,
tramite la ricostruzione dei termini tra
territori limitrofi e l’uso ripetitivo nel
tempo di toponimi.