UMRA
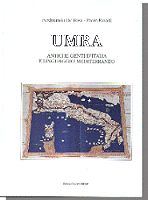
Presentazione (Ernesto Paleani)
Prefazione
Introduzione -L’avventura della storia
La storia:
Cap. I La valle del Metauro nella storia
Cap.II Gli Etruschi
Cap.III I Piceni
Cap. IV I Galli
Cap. V Gli Umbri
Cap. VI Ritrovamenti archeologici Umbri
Cap. VII Gli Umbri iguvini
Cap. VIII Il tempio a Giove Grabovio
Cap. IX Il tempio di Marte Nero al Nerone
Cap. X Gli Umra
Cap. XI La religione mediterranea e indoeuropea
Cap. XII La sopravvivenza del mito presso i Romani
Cap. XIII Il mito negli Umra
Cap. XIV Il Fanum fortunae
La lingua:
Cap. XV La lingua
Cap. XVI La lingua dei faraoni
Cap. XVII Il confronto
Bibliografia.£. 150.000
c/o
Ernesto Paleani Editore
Corso XX Settembre n.16/18
61043 CAGLI (Pesaro-Urbino)
IL TEMPO
La sacra montagna perenne
rinserra le spoglie di sposa,
caduta lontana nel tempo.
Antico Sole affretta il mezzogiorno
sulla calda Selvetta rocciosa,
ed il gelido buio ricorda pietoso
il braccio del compagno triste.
Incauta ed irriverente mano
disperde e sopisce nel vento,
l’eterna pietà e l’antico dolore,
ma non dissolve il filo d’amore.
Il territorio di confine fra Marche ed
Umbria, attorno alla via Flaminia, è sormontato da rocche e castelli,
resti feudali, nati ed organizzatisi sulle rovine delle antiche
fortificazioni.
A partire dalle guerre gotiche,
l'esercito romano- bizantino costruì le torri sui passi appenninici, a
difesa della pianura tiberina, da dove si giunge rapidamente a Roma.
Durante la dominazione longobarda le
rocche hanno assicurato il collegamento della cultura e della civiltà
romana da Roma a Ravenna e da qui, via mare, fino a Bisanzio, poggiando
sui capisaldi che proteggevano la via Gubbio- Urbino.
I nuclei principali di queste
costruzioni difensive in parte hanno poi costituito i feudi comitali della
zona dopo l'anno mille.
Gli Ubaldini della Carda, i Brancaleoni
di Piobbico, i Siccardi di S. Vitale, i Gabrielli di Cantiano e Frontone,
i Sicci di Montesecco e tante altre famiglie potenti rappresentano il
simbolo del periodo feudale misterioso ed affascinante che ha guidato le
popolazioni dei monti durante il Medio Evo.
La scarsa urbanizzazione mantiene nel
territorio ancora segni toponomastici, risalenti al popolo italico degli
Umbri, che, in piena epoca cristiana, continuava a sacrificare a Giove
Grabovio e Cerflo Martio e scrutava attento il volo augurale del picchio o
nefasto della cornacchia.
Il popolo umbro a ridosso dei due
versanti dell’Appennino ha continuato per molti secoli a pascolare le
mandrie sacre e profane sui prati dei massicci del Catria, Nerone e
Petrano ove hanno scolpito sempiterni tratturi.
Prima di loro altre genti si fregiavano
del nome ‘UMRO’ e adoravano sul monte-tempio GRABOVIO la triade Kerria
della dea Luna o dea Mater.
Puntuali alle Idi di Maggio correvano
la stessa corsa dei Ceri, per la fertilità e l’iniziazione dei giovani in
una società matriarcale, dove Melissa, la dea Ape, ogni anno ripeteva la
rituale uccisione dello sposo.
La dea Luna regolava lo scandire del
tempo e determinava le piogge, era così arbitra della Vita e della Morte.
Il primo quarto era la Vergine:
Amantea, la capra, simbolo della giovinezza.
La luna piena era la Ninfa orgiastica:
Io-Europa, la candida vacca.
L’ultimo quarto calante la Vegliarda:
Andrasta (colei cui non si fugge) o Nemesi o Ecate, cui, per l’aspetto
infernale, era sacra la scrofa.
Le triadi lunari ebbero, secondo i
luoghi, nomi diversi (Core-Persefone-Ecate, ecc.), mantenendo però
costanti significati e simboli.
L’avvento del patriarcato trasformò i
miti in funzione maschile e anche i nomi subirono questa evoluzione. Ad
esempio la dea della scrofa Çerfo o Cerdo diviene Çerfo, dio ikuvino e
italico dell’acqua, degli inferi, della guerra, cui spetta il sacrificio
di tre cinghiali.
Il cinghiale dalle lunghe zanne ricurve
è simbolo lunare, come la capra, lo stambecco, la giovenca.
Il Cristianesimo ha conservato l’antica
trinità mediterranea monoteista, a differenza della triade della cultura
indoeuropea, e, malgrado i nomi maschili è nel contenuto ancora femminile,
perché Amore. Nell’epifania del battesimo di Gesù, lo Spirito di Fuoco è
l’antica Ninfa, rappresentata dalla colomba, come Eurinome, la dea colomba del mito
pelasgico, o la sumerica Jahu, tradotto come Geova nella Bibbia.
La Rivelazione divina, crediamo, ha
tappe definite da Chi regge i sottili fili della vita.
A Gubbio la primitiva triade Kerria fu
sostituita da Giove, Marte Cubrio, Vofione, che determinano una serie di
triadi (Kerria, Çerfa ecc.), il cui significato potrebbe sfuggirci se non
ricerchiamo lumi l’ordinamento religioso più antico.
La lingua degli UMRA apparteneva alle terre del Mediterraneo e si era sviluppata con le prime civiltà sulle coste e sugli altopiani dell’Asia Minore. L’Egitto ereditò e produsse cultura che irradiò per quaranta secoli al mondo conosciuto.
Gli autori