|
D I P A R T I M E N T
O P O L I T I C H E D E L L A
Q U A L I T A' A M B I E N T A L E
|
INSUGHERATA
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il biotopo dell'Insugherata, posto nel settore
nord-ovest della città, è costituito da un'area
che si estende tra i nuclei insediativi sorti
sulle strade consolari della via Cassia e della
via Trionfale e la collina a ridosso del fosso
della Rimessola. Il settore nord del parco è
attraversato trasversalmente dal G.R.A. che
passando in viadotto non interrompe del tutto la
continuità del comprensorio.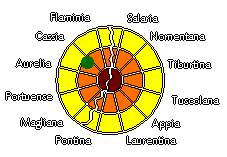 Per la sua collocazione l'area dell'Insugherata,
oltre a rappresentare un polmone verde
indispensabile per la città, insieme ai
comprensori del Pineto e di Veio tra cui si
inserisce come collegamento naturale, realizza un
cuneo di verde che dalle zone più centrali della
città si allarga in direzione nord ovest oltre i
confini delle aree urbanizzate. Morfologicamente
l'area dell'Insugherata si presenta molto
articolata e caratterizzata da estesi pianori su
modesti rilievi collinari tra cui è possibile
spaziare verso il sistema collinare a nord della
città, solcati da una serie di vallecole che
confluiscono nelle valli principali dell'Acqua
Traversa e dei suoi immissari fosso dell'Insugherata,
fosso della Rimessola e fosso dei Frati. Gli
elementi caratterizzanti di quest'area,
compromessa solo ai margini lungo le vie consolari
da intensi processi edificatori che non hanno
interessato le aree interne perché, ha differenza
di molte aree di proprietà privata, apparteneva
al patrimonio del Pio Istituto di S.Spirito ed
affittato per usi agricoli , sono la varietà e la
rarità in uno spazio limitato di paesaggi e
associazioni vegetali ancora prossimi allo stato
di naturalità e la presenza di specie poco
diffuse nella Regione come l'agrifoglio. Il
maggior pregio è dato dalla vegetazione di tipo
mediterranea, lembi residui di antiche foreste,
che ricoprono le pendici delle vallecole con
notevoli estensioni di sughere o si presentano in
bellissimi esemplari isolati di notevoli
dimensioni lasciati nei prati una volta a pascolo
a protezione delle greggi. Accanto a questa
vegetazione, amante del caldo e del terreno secco,
si trovano formazioni boschive di ambienti freschi
ed umidi. Coltivi o seminativi hanno sostituito
gli antichi pascoli nei pianori sulla sommità
delle collinette e nelle vallecole dove non
interessate da fitta vegetazione idrofila. Lungo
le consolari che seguono percorsi di crinale sono
distribuite notevoli emergenze archeologiche quali
resti di ville romane, sepolcri ed il tracciato
interrato dell'acquedotto Traiano -Paolo.
All'interno dell'area, che in parte corrispondeva
alla tenuta di "Inzuccherata", censita
al Catasto Alessandrino, si trovano inoltre resti
di una necropoli, numerose aree fittili nonchè
resti di una torre medioevale e dei casali
moderni. Le finalità da perseguire nella
realizzazione del Parco dell'Insugherata sono
volte a costituire un parco
naturalistico-archeologico che conviva con le
vocazioni agricole di parte del territorio. Sono
indirizzate pertanto al risanamento, alla tutela,
conservazione e valorizzazione dell'ambiente
naturalistico, al recupero e valorizzazione delle
emergenze archeologiche ed alla conservazione
delle vocazioni agricole del territorio.
Per la sua collocazione l'area dell'Insugherata,
oltre a rappresentare un polmone verde
indispensabile per la città, insieme ai
comprensori del Pineto e di Veio tra cui si
inserisce come collegamento naturale, realizza un
cuneo di verde che dalle zone più centrali della
città si allarga in direzione nord ovest oltre i
confini delle aree urbanizzate. Morfologicamente
l'area dell'Insugherata si presenta molto
articolata e caratterizzata da estesi pianori su
modesti rilievi collinari tra cui è possibile
spaziare verso il sistema collinare a nord della
città, solcati da una serie di vallecole che
confluiscono nelle valli principali dell'Acqua
Traversa e dei suoi immissari fosso dell'Insugherata,
fosso della Rimessola e fosso dei Frati. Gli
elementi caratterizzanti di quest'area,
compromessa solo ai margini lungo le vie consolari
da intensi processi edificatori che non hanno
interessato le aree interne perché, ha differenza
di molte aree di proprietà privata, apparteneva
al patrimonio del Pio Istituto di S.Spirito ed
affittato per usi agricoli , sono la varietà e la
rarità in uno spazio limitato di paesaggi e
associazioni vegetali ancora prossimi allo stato
di naturalità e la presenza di specie poco
diffuse nella Regione come l'agrifoglio. Il
maggior pregio è dato dalla vegetazione di tipo
mediterranea, lembi residui di antiche foreste,
che ricoprono le pendici delle vallecole con
notevoli estensioni di sughere o si presentano in
bellissimi esemplari isolati di notevoli
dimensioni lasciati nei prati una volta a pascolo
a protezione delle greggi. Accanto a questa
vegetazione, amante del caldo e del terreno secco,
si trovano formazioni boschive di ambienti freschi
ed umidi. Coltivi o seminativi hanno sostituito
gli antichi pascoli nei pianori sulla sommità
delle collinette e nelle vallecole dove non
interessate da fitta vegetazione idrofila. Lungo
le consolari che seguono percorsi di crinale sono
distribuite notevoli emergenze archeologiche quali
resti di ville romane, sepolcri ed il tracciato
interrato dell'acquedotto Traiano -Paolo.
All'interno dell'area, che in parte corrispondeva
alla tenuta di "Inzuccherata", censita
al Catasto Alessandrino, si trovano inoltre resti
di una necropoli, numerose aree fittili nonchè
resti di una torre medioevale e dei casali
moderni. Le finalità da perseguire nella
realizzazione del Parco dell'Insugherata sono
volte a costituire un parco
naturalistico-archeologico che conviva con le
vocazioni agricole di parte del territorio. Sono
indirizzate pertanto al risanamento, alla tutela,
conservazione e valorizzazione dell'ambiente
naturalistico, al recupero e valorizzazione delle
emergenze archeologiche ed alla conservazione
delle vocazioni agricole del territorio.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
Il territorio e' compreso nell'ambito del bacino
idrografico del Fosso dell'Acqua Traversa: la
morfologia del territorio e' notevolmente
articolata con valli solcate da fossi e collinette
più' o meno estese. Alle quote superiori ai 100
m. s.l.m. affiorano tufi del pleistocene
depositatisi a seguito dell'attività' del
complesso vulcanico sabatino. Sotto i tufi a quote
medie affiorano depositi prevalentemente sabbiosi
che si arricchiscono di argille che rendono i
suoli impermeabili: i tufi per lo più' di natura
tenera ed i terreni incoerenti come le sabbie sono
facilmente erosi o alterabili dalle acque
meteoriche creando spesso smottamenti anche di
rilevanti dimensioni: ciò' rappresenta una
particolare emergenza per quest'area. Nelle sabbie
e nei limi argillosi rilevante e' la presenza dei
fossili testimonianza dell'antico mare costiero,
che occupava tutto l'Agro Romano.
  Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
Il territorio rappresenta un rilevante corridoio
naturalistico tra i confini urbanizzati a Nord
della città ed il grande sistema Veio-Cesano.
Alla articolata morfologia del territorio
corrisponde una varietà' di paesaggio vegetale
con fitocenosi che si distribuiscono in funzione
dei gradienti di pendio, dell'umidità' dei suoli,
dell'esposizione, della temperatura. Le formazioni
boschive rispecchiano tipologie legate sia alla
macchia mediterranea che ad ambienti più' umidi e
freschi. Sulle pendici esposte a sud sud-ovest si
sviluppano boscaglie termofile con querce legate
alla vegetazione mediterranea dove si estende la
sughera (Quercus suber) in tipiche formazioni
compatte, il leccio (Quecus ilex), la roverella (Quercus
pubescens) associate allo strato arbustivo tipico
della macchia mediterranea con i cisti, l'erica,
il lentisco, la fillirea,. In condizioni più
mesofile e su pendici a settentrione si ha una
vegetazione decisamente diversa con un ambiente
forestale caratterizzato da boschi misti che
risultano i meglio conservati e di notevole
rilevanza in quanto tendenti allo sviluppo di una
foresta d'alto fusto: sono composti per lo strato
arboreo da carpino nero (Ostrya Carpinifolia)
orniello (Fraxinus ornus), carpino bianco, (Carpinus
betulus) farnia (Quercus Robur), acero (Acer
Campestre); il relativo sottobosco è
particolarmente ricco: da segnalare la presenza in
condizioni di naturalità di agrifoglio (Ilex
aquifolium) e di bucaneve (Galanthus nivalis).
Presente una facies a Castanea sativa con castagni
secolari ed una facies a Corylus avellanna con
splendidi esempi di noccioleti. I versanti meno
esposti a sud si arricchiscono di essenze arboree
caducifoglie quali il cerro (Quercus cerris), il
nocciolo (Corylus avellana), l'orniello (Fraxinus
ornus). Lungo i corsi d'acqua e nelle aree umide
di fondovalle sono presenti: salice bianco (Salix
alba) pioppo bianco (Populus alba e popolamenti a
cannuccia palustre (Phragmites australis))
cannuccia comune (Arundo donax); notevole è la
presenza di felci: Polisticum setiferum, Asplenium
onopteris, Equisetum Telemateja mentre le zone
umide periodicamente allagate sono ricche di
specie dei generi Carex e Juncus. Presenti inoltre
varie specie di orchidee spontanee tra cui la
Platantera comune.
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
L'area è riccamente popolata sia dall'entomofauna
che dai vertebrati. Tra i mammiferi oltre il
riccio (Erinaceus europaeus), sono presenti la
talpa (Talpa sp) la volpe comune (Vulpes vulpes)
la donnola (Mustela nivalis), tra i roditori
troviamo l'istrice (Hystix cristata), il
moscardino (Muscardinus avellanarius), il topo
selvatico (Apodemus sylvaticus), l'arvicola di
Savi (Microtus Savi). Numerosi sono gli uccelli:
nidificante è il gheppio (Falco tinnunculus),
nonchè il fagiano (Phasianus colchicus), la
tortora (Streptopelia turtur) ed il cuculo (Cuculus
canorus). Sono presenti, inoltre, tutti i Rapaci
notturni nidificanti a Roma e cioè il barbagianni
(Tyto alba), l'assiolo (Otus scops), la civetta (Athene
noctua), l'allocco (Strix aluco) ed il gufo comune
(Asio otus), da segnalare anche la nidificazione
del gruccione (Merops apiaster), dell'upupa (Upupa
epops), del picchio verde (Picus viridis) e del
picchio rosso maggiore (Picoides maior). Tra i
rettili abbastanza comuni sono l'orbettino (Anguis
fragilis), il cervone (Elaphe quatorlineata), la
biscia dal collare (Natrix natrix) il saettone (Elaphe
longissima) ed il Biacco (Coluber viridiflavus)
nonchè le specie complementari nella catena
alimentare come il topolino delle case ed il
riccio. Numerosa la presenza di anfibi legati alle
zone umide ed ai corsi d'acqua tra cui il tritone
punteggiato (Triturus vulgaris), il rospo comune (Bufo
bufo) il rospo smeraldino (Bufo viridis), la
raganella ( Hyla arborea) , la rana verde (Rana
esculenta) e tra i rettili la testuggine d'acqua (Emys
orbicularis).
 Preesistenze storiche:
Preesistenze storiche:
L'area dell'Insugherata in parte corrispondente
all'antica tenuta già censita nel Catasto
Alessandrino (1660) con il nome di
"Inzuccherata". risulta compresa nel
triangolo territoriale percorso dal Fosso
dell'Acqua Traversa e delimitato dalla via Cassia
e dalla via Trionfale. Le due antiche strade, che
seguono percorsi di crinale, individuano anche la
fondamentale innervatura del sistema territoriale.
Le principali emergenze archeologiche sono
distribuite, infatti, lungo il tracciato delle due
strade. Lungo La via Cassia si registrano resti di
ville romane e dei relativi sepolcri, quali la
villa di Lucio Vero, nell'ambito di villa Manzoni,
ed il sepolcro di P. Vibio Mariano che ha tramesso
all'intera contrada il toponimo di " Tomba di
Nerone". Lungo la via Trionfale, oltre al
passaggio in condotto sotterraneo dell'acquedotto
Traiano-Paolo, si segnalano i rivestimenti
relativi all'ambito arcaico di Colle S.Agata,
ormai non più rilevabili sul posto. Nella zona
interna, caratterizzata da pianori separati dai
tributari di destra del Fosso dell'Acqua Traversa,
si notano affioramenti ceramici indicanti siti di
insediamenti romani ed i resti di una torre
medioevale già registrata in IGM con la dicitura
"ruderi". L'area della tenuta, quasi
completamente boschiva, in epoca medioevale
risulta già coltivata con appezzamenti vignati;
rimane visibile sulla via Trionfale, sebbene
circondato dalle moderne urbanizzazioni, l'antico
casale dell'Insugherata. Alla confluenza delle due
strade, merita particolare attenzione il borgo
della Giustiniana che ripete un precedente
agglomerato rustico di età medioevale e, forse,
romana.
|
|
VALLE DEI
CASALI
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
La Valle dei Casali ha avuto nel territorio
dell'Agro Romano, per la sua collocazione tra il
centro urbano e le grandi vie di comunicazioni, un
particolare valore le cui caratteristiche di
omogeneità storico-ambientale e d'insieme sono
ancora chiaramente leggibili. L'elemento dominante
di questa area, sviluppatosi nella zona a partire
dall'epoca tardo rinascimentale, risiede nella
conservazione dell'articolato sistema di casali di
estremo interesse tipologico e storico ambientale
posti in un contesto di campagna romana costituita
da coltivazioni agricole e prati pascoli che si
integrano con la vegetazione umida dei corsi
d'acqua, nel quale emerge la settecentesca villa
York, raro esempio di tipica "vigna
romana" realizzata secondo la concezione
inglese del paesaggio naturale. Da un punto di vista topografico la valle si
estende per oltre 6 Km con direzione nord-sud da
Villa Panphyli e via Aurelia Antica fino ai monti
del Trullo ed è delimitata storicamente ad est e
ad ovest da strade di crinale: sul proseguimento
della via Olimpica , la via del Casaletto ed a
partire dal Forte Aurelio, via di Bravetta e Via
Casetta Mattei. Trasversalmente la valle è
attraversata di via della Nocetta che costeggia
villa Panphily e da via Portuense.
Morfologicamente l'area del parco si presenta come
un altopiano ondulato che con un movimento di
collinette degrada verso il Tevere, inciso da nord
a sud dal fosso dell'Affogalasino che riceve le
acque di numerosi rigagnoli , dal fosso di S.
Passera e dal fosso di Papa Leone. Lungo gli assi
stradali citati e la via del Trullo è addensata
una intensa urbanizzazione mentre le aree interne
risultano interessate solo marginalmente da
edificazione sparsa e presentano ancora notevoli
caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.
L'area della Valle dei Casali risulta inoltre
strategica per collegare tra loro il sistema di
ville storiche del settore sud ovest della città
costituito da Villa Panphily, Villa Carpegna,
Villa Abamelek, Villa Piccolomini, Villa Flora e
Villa Bonelli realizzando un corridoio di verde
fino alle sponde del Tevere. Tra le aree che hanno
conservato intatte le caratteristiche
storico-ambientali in particolare ricordiamo la
villa York, i casali posti sulla collinetta
percorsa da vicolo Silvestri e sull'area del Buon
Pastore a nord ed al di là della via Portuense,
il complesso di Villa de Angelis ed il monte del
Trullo, limite sud estremo del parco, che si
affaccia sulla Valle del Tevere. Le peculiarità
del parco urbano della valle dei Casali è quindi
quella di un parco- campagna inserito in un
contesto urbanizzato, le cui finalità dovranno
essere la tutela, conservazione e valorizzazione
naturalistica, il recupero e valorizzazione della
villa York, del sistema dei Casali e della
Cappella di Sant'Agata nonchè la protezione,
riassetto e l'eventuale rilancio delle vocazioni
agricole.
Da un punto di vista topografico la valle si
estende per oltre 6 Km con direzione nord-sud da
Villa Panphyli e via Aurelia Antica fino ai monti
del Trullo ed è delimitata storicamente ad est e
ad ovest da strade di crinale: sul proseguimento
della via Olimpica , la via del Casaletto ed a
partire dal Forte Aurelio, via di Bravetta e Via
Casetta Mattei. Trasversalmente la valle è
attraversata di via della Nocetta che costeggia
villa Panphily e da via Portuense.
Morfologicamente l'area del parco si presenta come
un altopiano ondulato che con un movimento di
collinette degrada verso il Tevere, inciso da nord
a sud dal fosso dell'Affogalasino che riceve le
acque di numerosi rigagnoli , dal fosso di S.
Passera e dal fosso di Papa Leone. Lungo gli assi
stradali citati e la via del Trullo è addensata
una intensa urbanizzazione mentre le aree interne
risultano interessate solo marginalmente da
edificazione sparsa e presentano ancora notevoli
caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.
L'area della Valle dei Casali risulta inoltre
strategica per collegare tra loro il sistema di
ville storiche del settore sud ovest della città
costituito da Villa Panphily, Villa Carpegna,
Villa Abamelek, Villa Piccolomini, Villa Flora e
Villa Bonelli realizzando un corridoio di verde
fino alle sponde del Tevere. Tra le aree che hanno
conservato intatte le caratteristiche
storico-ambientali in particolare ricordiamo la
villa York, i casali posti sulla collinetta
percorsa da vicolo Silvestri e sull'area del Buon
Pastore a nord ed al di là della via Portuense,
il complesso di Villa de Angelis ed il monte del
Trullo, limite sud estremo del parco, che si
affaccia sulla Valle del Tevere. Le peculiarità
del parco urbano della valle dei Casali è quindi
quella di un parco- campagna inserito in un
contesto urbanizzato, le cui finalità dovranno
essere la tutela, conservazione e valorizzazione
naturalistica, il recupero e valorizzazione della
villa York, del sistema dei Casali e della
Cappella di Sant'Agata nonchè la protezione,
riassetto e l'eventuale rilancio delle vocazioni
agricole.
 Aspetti geomorfologici
Aspetti geomorfologici
La valle è caratterizzata morfologicamente da un
altopiano che raggiunge gli 80 m. s.l.m. e degrada
verso il Tevere con un andamento ondulato
movimentato da collinette che interrompono
l'aspetto continuo tipico della Campagna romana ;
da un punto di vista geologico rispecchia la
stratificazione presente nel sottosuolo di Roma:
sulle antiche rocce calcaree sono sovrapposte le
argille, le sabbie e ghiaie di origine marina e
fluviale a loro volta ricoperte dai depositi
vulcanici; l'azione erosiva del Tevere e dei suoi
affluenti ha poi disarticolato il territorio
formando diverse fascie pianeggianti con depositi
alluvionali di sabbie e ghiaie.
L'altopiano è inciso da Nord a Sud da Fosso dell'Affogalasino,
che riceve le acque del Fosso della Nocetta e di
un notevole numero di rigagnoli minori suoi
influenti a destra e a sinistra lungo il suo
decorso fino alla via Portuense, dove è
affiancato da altri fossi : il Fosso di S.Passera
e il Fosso di Papa Leone.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
La vegetazione che ricopre il territorio della
Valle dei Casali risponde all'uso del suolo
prevalentemente agricolo, alla presenza di una
fitta rete di fossi e del fiume Tevere ed alla
adiacenza al tessuto urbanizzato della città. La
valle si insinua in direzione sud-ovest nel
tessuto della città e, analogamente a quanto
accade nel quadrante sud-est della città, con
l'area della valle della Caffarella, rappresenta
un cuneo di verde che collega le ampie piane
alluvionali del Tevere e le pianure costiere con i
territorio edificato ed il centro della città
attraverso la Villa Pamphily ed il Gianicolo. La
maggior parte del territorio dei fondovalle è
adibito ad uso agricolo con coltivazioni che si
estendono anche sulle modeste alture dolcemente
ondulate generalmente coltivate ad uliveti ed a
vite. Le aree residuali dei fondavalle e le aree
delle collinette e dei pendii, con precedente
utilizzazione agricola, sono caratterizzate da una
copertura vegetazionale di comunità dominate da
varie specie di graminacee che si sviluppano su
terreni incolti quali il falso grano (Dasypirum
villosum), il forasacco (Bromus gussonei). In aree
incolte di bordo, limitrofe l'abitato, e su suoli
più ricchi di nutrienti prevalgono comunità di
orzo mediterraneo (Hordeum leporinum) e miglio e
pabbio. (Panico-Setarion comm) Le aree a
prato-pascolo cespugliato ed arborato ed alcune
pendici sfuggite a coltura sono caratterizzate da
vegetazione seminaturale riconducibile al climax
della Campagna romana caratterizzata per lo strato
arboreo da elementi di leccio (Quercus ilex),
cerro (Quercus Cerris), acero (Acer Campestre) e
per lo strato arbustivo da ginestra (Spartium
junceum), alaterno(Rhamnus alaterno). Sia i
coltivi che la vegetazione degli incolti e le
fitocenosi a prato-pascolo si integrano con la
vegetazione umida dei corsi d'acqua caratterizzata
dalla presenza di comunità a salice bianco (Salix
alba), olmo (Ulmus minor), pioppo (Populus alba )
, canneti a cannuccia palustre (Phragmites
australis) e canneti di origine artificiale: canna
comune (Arundo donax). Sempre in zone
prevalentemente umide si sviluppano siepi a
prugnolo (Prunus spinosa) e roveti a rovo (Rubus
ulmifolius). Da segnalare la presenza di
alberature di origine antropica utilizzate per
delimitare filari o per uso ornamentale ormai da
tempo introdotte che rappresentano una
cararatteristica tipica del territorio romano tra
esse: pini, cipressi,cedri, palme.
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Le comunità faunistiche presenti sono tipiche dei
sistemi agricoli e degli ambienti verdi aperti di
estensione limitata e soggetti a disturbo
antropico tra i mammiferi troviamo la volpe (Vulpes
vulpes) e la donnola (Mustela nivalis). Tra i
roditori si registra la presenza dell'arvicola di
Savi (Microtus savi), il topo selvatico (Apodemus
sylvaticus), il topolino selvatico (Mus domesticus),
il ratto nero (Rattus rattus) e tra gli
insettivori il riccio (Erinaceus europaeus), , la
crocidura minore (Crocidura suaveolens) ed i
mustiolo ( Suncus etruscus). La presenza di siepi
intercalate ai coltivi, ricche di frutti favorisce
il rifugio, l'alimentazione e la riproduzione
dell'avifauna: presenti il fringuello (Frigilla
coelebes), il verzellino (Serinus serinus) , la
cornacchia grigia (Corvus corone cornix), il
rondone (Apus apus), la rondine (Hirundo rustica).
Tra l'avifauna delle vaste aree erbacee aperte
troviamo comunità ornitiche tipiche appartenenti
ai passeriformi quali l'allodola (Aluada arvensis)
e la calandrella (Calandrella brachydactyla). Per
quanto riguarda gli uccelli ricordiamo ancora il
Gheppio (Falco tinnanculus) ed il nibbio bruno (Milvus
migrans) presente principalmente per ragioni
trofiche. Tra i rapaci notturni sono rinvenibili
il barbagianni (Tyto alba) e la civetta (Athene
noctua) tipici frequentatori dei casali
abbandonati nonchè l'Allocco (Strix aluco)
diffuso nelle zone boscate. Tra i rettili
discretamente diffuse risultano la lucertola
campestre (Podarcis sicula) e la lucertola
muraiola (P. muralis) mentre più raro è il
ramarro (Lucertola viridis ); nelle abitazioni e
nei casali abbandonati e poi possibile rinvenire
anche l'emidattilo (Hemidactylus turcicus) ed il
geco comune (Tarentola mauritanica). Tra i
serpenti ricordiamo il biacco (Coluber
Viridiflavus) e il saettone (Elaphe longissima ).
Gli anfibi sono rappresentati dal rospo comune (Bufo
bufo) e dalla rana verde (Rana esculenta).
 Preesistenze storiche:
Preesistenze storiche:
Le non abbondanti testimonianze archeologiche,
soprattutto necropoli e catacombe, risultano
concentrate nell'ambito della Villa Pamphily e
lungo le antiche direttrici stradali della via
Aurelia, della via Vitellia e della via Portuense.
Altre presenze, riferibili sostanzialmente a Ville
rustiche ed ai relativi impianti tecnici, sono
state episodicamente segnalate dalla bibliografia
specialistica in materia nella zona compresa tra
le dorsali collinari percorse dalla via del
Casaletto e dalla via di Casetta Matteri che
probabilmente ripetono antichi tracciati stradali.
L'interesse maggiore della zona risiede, invece,
nella conservazione dell'articolato sistema di
ville e di casali che riflettono il marcato
frazionamento terriero sviluppatosi nella zona a
partire dall'epoca tardo rinascimentale. Fra i
complessi più significativi si segnalano la Villa
York, la Villa Consorti, i Casali in vicolo
Silvestri e nell'area del Buon Pastore, la serie
di casali lungo via del Casaletto fino al
complesso della Beata Vergine del Monte Carmelo e
della Parrocchietta; si segnalano, al di là della
via Portuense, il complesso di Villa De Angelis,
lungo il vicolo Clementi e, lungo via
dell'Imbrecciato, il Casale Pino Lecce e quello di
Torre Barricello. Altre significative strutture
risultano drasticamente ristrutturate ed inserite
in recenti complessi edilizi.
|
|
VEIO
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il vasto comprensorio del Parco di Veio, area di
elevatissimo valore storico, archeologico e
paesaggistico, posta nel settore nord della città
e delimitata dalle consolari di via Cassia e di
via Flaminia e delimitata dal limite del
territorio comunale, insieme al Parco dell'Appia
Antica, dell'Aniene e del Tevere rappresenta uno
dei quattro cunei di verde di penetrazione
previsti dal P.R.G. che da nord a sud si immette
fino al centro della città.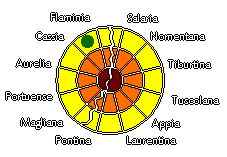 Nell'ambito dei confini del Comune di Roma esso
costituisce solo una parte (circa 6.000 ha) del più
ampio Parco di Veio previsto dal Sistema dei
Parchi e delle Riserve della Regione Lazio che
vede coinvolti oltre al Comune di Roma, i comuni
di Formello, Campagnano, Sacrofano, Morlupo e
Castelnuovo di Porto per un estensione di circa
16.000 ha . Morfologicamente il comprensorio del
parco, delimitato ad est e ad ovest dai crinali
percorsi dalle consolari, è costituito da
altipiani in tufo utilizzati a coltivazioni
agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da
fossi, il fosso della Crescenza, il fosso della
Valchetta , e quello della Torraccia, che si
immettono nel Tevere, e da pendici ricoperte da
folti boschi rimasti ancora allo stato naturale,
tutti elementi caratteristici della struttura
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La
morfologia stessa di quest'area, antropizzata fin
dai tempi della civiltà etrusca, l'ha preservata
probabilmente dalla più massiccia urbanizzazione
che ha interessato altre parti del territorio
comunale, contribuendo a conservare vaste aree di
intenso valore paesaggistico che negli ultimi anni
tuttavia sono state sempre più invase da
edificazioni sparse, lottizzazioni convenzionate o
spesso abusive, e grandi infrastrutture come
l'ospedale di S. Andrea e le costruzioni della
Telecom. L'edificazione intensiva ha interessato
soprattutto le aree a ridosso delle consolari
mentre nuclei di edilizia spontanea sono sorti
nell'area di Labaro - Prima Porta e lungo la via
Sacrofanese e via di Santa Cornelia. Gli elementi
che caratterizzano questo tratto di Agro Romano, e
ne fanno un parco dalle multiformi vocazioni sono
la sua morfologia strettamente connessa alla
storia degli insediamenti, gli aspetti
naturalistici e il suo paesaggio. L'intero settore
territoriale dove più intenso è stato l'incontro
della civiltà etrusca con quella latina, è
dominata dalla presenza della città di Veio,
dalle necropoli disposte nei pianori tufacei e
dalle sue strutture di comunicazione con Roma ed i
centri etruschi vicini, tra cui Via Cassia, la Via
Veientana, ancora riconoscibile e punteggiata da
presenze monumentali ed un asse trasversale che
congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla Domus
culta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di
grande interesse archeologico oltre all'abitato ed
alle necropoli di Veio sono alcune grandi ville di
epoca romana fra le quali Villa di Livia, la Villa
Lucio, il sepolcro dei Masoni, la Tomba dei
Veienti, il sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di
Malborghetto oltre ad altre anonime strutture
insediative poste in diverse zone del parco. Di
epoca medioevale e rinascimentale, oltre alla
vetusta domus culta Capracorum, sono gli
insediamenti di Isola Farnese, di Tor Vergara,
della Crescenza, della Storta e della Giustiniana
oltre ed una serie di strutture minori di difesa e
sfruttamento agricolo del territorio lungo le
principali direttive viarie. L'articolazione del
territorio riflette ancora il relativo
frazionamento in vigne vicino alla città ed in
grandi tenute nelle parti più periferiche a cui
fanno riferimento gli antichi casali del Fosso,
del Pino, dei Tre Archi, di Santa Cornelia, della
Vacchereccia, di Buon Ricovero, di Tor Vergara
della Spizzichina, di Ospedaletto Annunziata,
della Crescenza, di Monte Oliviero, della
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli
aspetti naturalistici sono vari e ricchissimi
rispondenti all'articolata morfologia del
territorio. Sono presenti boschi della macchia
mediterranea, soprattutto nella parte nord, boschi
legati ad ambienti più termofili dominati dalla
presenza di roverella mentre nelle condizioni più
mesofile prevalgono boschi di querceti caduciformi.
La vegetazione lungo le vie dei fossi rispecchia
le associazioni vegetali tipiche degli ambienti
umidi con presenza di pioppi, ontani e salici. Non
mancano inoltre specie rare, soprattutto nei
cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi e relitti
di antiche foreste. L'agricoltura che
rappresentava per gli etruschi insieme al
commercio il cardine dell'economia cittadina
malgrado le tante trasformazioni avvenute
attraverso i secoli ancora oggi caratterizza
fortemente il paesaggio di questo territorio.
Nell'ambito dei confini del Comune di Roma esso
costituisce solo una parte (circa 6.000 ha) del più
ampio Parco di Veio previsto dal Sistema dei
Parchi e delle Riserve della Regione Lazio che
vede coinvolti oltre al Comune di Roma, i comuni
di Formello, Campagnano, Sacrofano, Morlupo e
Castelnuovo di Porto per un estensione di circa
16.000 ha . Morfologicamente il comprensorio del
parco, delimitato ad est e ad ovest dai crinali
percorsi dalle consolari, è costituito da
altipiani in tufo utilizzati a coltivazioni
agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da
fossi, il fosso della Crescenza, il fosso della
Valchetta , e quello della Torraccia, che si
immettono nel Tevere, e da pendici ricoperte da
folti boschi rimasti ancora allo stato naturale,
tutti elementi caratteristici della struttura
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La
morfologia stessa di quest'area, antropizzata fin
dai tempi della civiltà etrusca, l'ha preservata
probabilmente dalla più massiccia urbanizzazione
che ha interessato altre parti del territorio
comunale, contribuendo a conservare vaste aree di
intenso valore paesaggistico che negli ultimi anni
tuttavia sono state sempre più invase da
edificazioni sparse, lottizzazioni convenzionate o
spesso abusive, e grandi infrastrutture come
l'ospedale di S. Andrea e le costruzioni della
Telecom. L'edificazione intensiva ha interessato
soprattutto le aree a ridosso delle consolari
mentre nuclei di edilizia spontanea sono sorti
nell'area di Labaro - Prima Porta e lungo la via
Sacrofanese e via di Santa Cornelia. Gli elementi
che caratterizzano questo tratto di Agro Romano, e
ne fanno un parco dalle multiformi vocazioni sono
la sua morfologia strettamente connessa alla
storia degli insediamenti, gli aspetti
naturalistici e il suo paesaggio. L'intero settore
territoriale dove più intenso è stato l'incontro
della civiltà etrusca con quella latina, è
dominata dalla presenza della città di Veio,
dalle necropoli disposte nei pianori tufacei e
dalle sue strutture di comunicazione con Roma ed i
centri etruschi vicini, tra cui Via Cassia, la Via
Veientana, ancora riconoscibile e punteggiata da
presenze monumentali ed un asse trasversale che
congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla Domus
culta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di
grande interesse archeologico oltre all'abitato ed
alle necropoli di Veio sono alcune grandi ville di
epoca romana fra le quali Villa di Livia, la Villa
Lucio, il sepolcro dei Masoni, la Tomba dei
Veienti, il sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di
Malborghetto oltre ad altre anonime strutture
insediative poste in diverse zone del parco. Di
epoca medioevale e rinascimentale, oltre alla
vetusta domus culta Capracorum, sono gli
insediamenti di Isola Farnese, di Tor Vergara,
della Crescenza, della Storta e della Giustiniana
oltre ed una serie di strutture minori di difesa e
sfruttamento agricolo del territorio lungo le
principali direttive viarie. L'articolazione del
territorio riflette ancora il relativo
frazionamento in vigne vicino alla città ed in
grandi tenute nelle parti più periferiche a cui
fanno riferimento gli antichi casali del Fosso,
del Pino, dei Tre Archi, di Santa Cornelia, della
Vacchereccia, di Buon Ricovero, di Tor Vergara
della Spizzichina, di Ospedaletto Annunziata,
della Crescenza, di Monte Oliviero, della
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli
aspetti naturalistici sono vari e ricchissimi
rispondenti all'articolata morfologia del
territorio. Sono presenti boschi della macchia
mediterranea, soprattutto nella parte nord, boschi
legati ad ambienti più termofili dominati dalla
presenza di roverella mentre nelle condizioni più
mesofile prevalgono boschi di querceti caduciformi.
La vegetazione lungo le vie dei fossi rispecchia
le associazioni vegetali tipiche degli ambienti
umidi con presenza di pioppi, ontani e salici. Non
mancano inoltre specie rare, soprattutto nei
cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi e relitti
di antiche foreste. L'agricoltura che
rappresentava per gli etruschi insieme al
commercio il cardine dell'economia cittadina
malgrado le tante trasformazioni avvenute
attraverso i secoli ancora oggi caratterizza
fortemente il paesaggio di questo territorio.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
L'intera area figura come naturalmente compresa in
un ambito territoriale chiuso ad est ed a ovest
dai crinali attraversati oggi dalla via Flaminia e
dalla via Cassia ,a nord dalla dorsale che da
Campagnano arriva a Morlupo e fa da spartiacque
con il bacino del Treya, a sud dal fiume Tevere.
L'attuale conformazione orografica della regione
è dovuta all'attività dell'apparato vulcanico
sabatino con depositi rappresentati in modo
prevalente da materiali piroclastici accompagnati
da affioramenti lavici. L'attività sabazia
riconducibile a tre grandi periodi vede la
progressiva stratificazione dei depositi
vulcanici: tra gli affioramenti più antichi i
"Tufi di Rio Filetto" ed il "Tufo
di Riano della via Flaminia", a cui in una
seconda fase, è seguita la formazione del
"Tufo Giallo della via Tiberina", legato
alla grande attività collegata all'apparato di
Sacrofano.ed successivamente la formazione del
" Tufo giallo di Sacrofano" e del
"Tufo di Baccano". La morfologia del
territorio ha nel complesso un aspetto dolcemente
ondulato: non vi sono rilievi particolarmente
elevati, la maggior parte delle alture derivano
dai crateri o dai coni dei depositi vulcanici così
come le depressioni rappresentano piccole o grandi
bocche crateriche come la grande valle di
Sacrofano.
I principali bacini idrografici che attraversano
l'area sono percorsi dal Fosso della Crescenza,
dal Fosso della Valchetta e dal Fosso della
Torraccia. Tali bacini possono essere a loro volta
suddivisi in bacini parziali con i corsi d'acqua
del Fosso dell'Acqua Traversa, Fosso dei
Pantanicci, Fosso del Piordo, Fosso della Mola dei
Morti , Fosso della Mola di Formello e del Fosso
di Pietra Pertusa. Presenti numerose sorgenti
anche termominerali in località Selciatella e
Ponte Sodo che sgorgano lungo il torrente
Valchetta. Altre sorgenti sono localizzate nella
zona di S.Antonino: la sorgente di S.Antonino
lungo il Fosso omonimo, la sorgente dell'Acqua
Ferruginosa lungo il Fosso di Citerna e la
sorgente del Fosso dell'Acqua Forte.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
In relazione alle differenziazioni paesaggistiche
dell'area si distinguono spazi
naturali-seminaturali e spazi antropici
prevalentemente agrari ed urbani dove la
vegetazione è spesso caratterizzata da essenze
antropiche introdotte a scopo ornamentale . Negli
spazi naturali e seminaturali, generalmente
presenti dove l'andamento morfologico del suolo
non ha favorito l'estendersi delle colture,
prevalgono estensioni di macchia mediterranea con
fitti strati arborei ed arbustivi . Le diverse
tipologie di fitocenosi presenti rispondono alla
diversa natura dei suoli, al grado di umidità,
alla esposizione, all'andamento morfologico del
territorio. Relativamente alle condizioni
bioclimatiche in ambiente xerofilo prevalgono
boschi, maggiormente localizzati a nord del
territorio, caratterizzati da querceti sempreverdi
in prevalenza a leccio (Quercus ilex) e sughera (Quercus
suber) ed il relativo fitto sottobosco è
caratterizzato dalla presenza di cisti, siepi ad
erica e corbezzolo, fillirea, mirto e lentisco.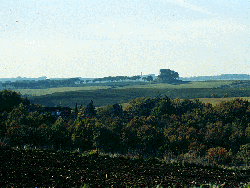 Presenti boschi con dominanza di roverella (Quercus
pubescens) in ambienti più termofili. In
condizioni più mesofile prevalgono boschi misti
di querceti caducifoglie a cerro (Quercus cerris)
farnia (Quercus robur), acero (Acer campestre).
Presenti boschi misti a cerro (Quercus cerris),
carpino (Carpinus betulus) e castagno (Castanea
sativa). Particolarmente estese le siepi a
prugnolo (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus
monogyna), le siepi a corniolo (Cornus sanguinea)
ed a rovo (Rubus ulmifolius); è presente la
ginestra (Spartium junceum); quest' ultima si
estende anche in formazioni monofitiche su
prati-pascoli su substrato tufaceo. La vegetazione
erbacea delle aree a prato e prato-pascolo ha
subito la selezione dovuta all'uso del suolo. La
vegetazione igrofila dei bacini idrografici e
delle rive dei fossi rispecchia le associazioni
vegetali tipiche con presenza di pioppi, ontani,
salici,olmi, sambuchi. Di notevole entità è la
distribuzione di felci di cui sono state
riscontrate forme arcaiche relitte. Da segnalare
relitti delle antiche foreste "Moesia"
ed "Arsia", di epoca etrusco-romana con
elementi mesofili come Quercus robur, Carpinus
betulus, Corylus avellana. Peculiari anche da un
punto di vista floristico le stazioni botaniche
presenti nelle gallerie e nei cunicoli tufacei
scavati dagli Etruschi con specie rare tra le
quali: Gymnogramme Leptophyila , Carex remota,
Phytilis scolopendrium, Cardamine amara segnalate
dalla Commmissione Straordinaria istituita dalla
Regione Lazio per lo studio dei biotopi da
proteggere nel Lazio. Nelle aree periurbane ed ai
margini dei campi sono presenti nuclei di falsa
acacia (Robinia pseudacacia) mentre le aree
adiacenti l'urbanizzato e i grandi viali di
accesso ai casali ed alle ville sono
caratterizzate da essenze di impianto artificiale
introdotte in tempi più o meno recenti costituiti
principalmente da pini , eucalitti, cedri ,
oleandri.
Presenti boschi con dominanza di roverella (Quercus
pubescens) in ambienti più termofili. In
condizioni più mesofile prevalgono boschi misti
di querceti caducifoglie a cerro (Quercus cerris)
farnia (Quercus robur), acero (Acer campestre).
Presenti boschi misti a cerro (Quercus cerris),
carpino (Carpinus betulus) e castagno (Castanea
sativa). Particolarmente estese le siepi a
prugnolo (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus
monogyna), le siepi a corniolo (Cornus sanguinea)
ed a rovo (Rubus ulmifolius); è presente la
ginestra (Spartium junceum); quest' ultima si
estende anche in formazioni monofitiche su
prati-pascoli su substrato tufaceo. La vegetazione
erbacea delle aree a prato e prato-pascolo ha
subito la selezione dovuta all'uso del suolo. La
vegetazione igrofila dei bacini idrografici e
delle rive dei fossi rispecchia le associazioni
vegetali tipiche con presenza di pioppi, ontani,
salici,olmi, sambuchi. Di notevole entità è la
distribuzione di felci di cui sono state
riscontrate forme arcaiche relitte. Da segnalare
relitti delle antiche foreste "Moesia"
ed "Arsia", di epoca etrusco-romana con
elementi mesofili come Quercus robur, Carpinus
betulus, Corylus avellana. Peculiari anche da un
punto di vista floristico le stazioni botaniche
presenti nelle gallerie e nei cunicoli tufacei
scavati dagli Etruschi con specie rare tra le
quali: Gymnogramme Leptophyila , Carex remota,
Phytilis scolopendrium, Cardamine amara segnalate
dalla Commmissione Straordinaria istituita dalla
Regione Lazio per lo studio dei biotopi da
proteggere nel Lazio. Nelle aree periurbane ed ai
margini dei campi sono presenti nuclei di falsa
acacia (Robinia pseudacacia) mentre le aree
adiacenti l'urbanizzato e i grandi viali di
accesso ai casali ed alle ville sono
caratterizzate da essenze di impianto artificiale
introdotte in tempi più o meno recenti costituiti
principalmente da pini , eucalitti, cedri ,
oleandri.
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Area di notevole valore da un punto di vista
faunistico. Tra i mammiferi più interessanti
presenti ricordiamo numerosi mustelidi quali la
faina (Foina martes), la martora (Martes martes),
la donnola (Mustela nivalis) ed il tasso (Meles
meles); diffusa è la volpe (Vulpes vulpes) mentre
più raro risulta l'istrice (Hystrix cristata).Particolarmente
ricca è l'erpetofauna, presenti il biacco (Coluber
viridiflavus), la vipera (Vipera aspis), il
saettone (Elaphe longissima), il cervone (Elaphe
quatorlineata) che giustifica la presenza di
numerosi rapaci che nidificano nei costoni
tufacei: il nibbio bruno (Milvus migrans), la
poiana (Buteo Buteo) osservabile per lo più in
zone aperte, lo sparviero (Accipiter nisus) in
zone boscate, l'albanella minore (Circus pygargus)
che nidififca nelle zone erbose e coltivate, molto
comune infine è il gheppio (Falco tinnanculus).
Tra gli stringiformi presenti la civetta (Athena
noctua), il barbagianni (Tito alba), il gufo
comune (Asio otus), l'assiolo (Otus scops),
l'allocco (Strix aluco). Particolarmente
abbondante in tempi passati la presenza della
tartaruga (Testudo graeca). Nelle zone umide
albergano il tritone crestato (Triturus cristatus),
la rana verde (Rana esculenta), il tritone
punteggiato (Triturus vulgaris), la raganella (Hyla
arborea), la rana greca (Rana graeca), la rana
agile (Rana dalmantina), la biscia dal collare (Natrix
natrix), la testuggine d'acqua (Emys orbicularis).
Lungo i corsi e negli specchi d'acqua è possibile
osservare la gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis),
il pendolino (Remiz pendulinus) e la ballerina
gialla (Motacilla cinerea). L'avifauna è
particolarmente ricca sia nelle specie stanziali
che di passo: tra le prime riscontriamo la taccola
(Corvus monedula), la cornacchia grigia (Corvus
cornix), la capinera (Motacilla alba); fra le
specie di passo: la beccaccia (Scolopax rusticola),
l'allodola (Alauda arvensis), l'usignolo (Luscinia
megaryncha). Nelle zone boscate si rinvengono, tra
gli altri, il torcicollo (Jynx torquilla ), il
picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso
maggiore (Picoides major), il cuculo (Cuculus
canorus ) e la tortora (Streptopelia turtur).
Numerosi sono i passeriformi notevolmente
rappresentati. Presente anche la fauna migratrice.
 Preesistenze storiche:
Preesistenze storiche:
L'intero settore teritoriale compreso nel Parco
Regionale appare dominato dalla presenza
dell'abitato antico di Veio e delle necropoli
disposte sui vicini pianori tufacei. L'area della
città antica risulta ubicata a breve distanza dal
crinale spartiacque precocemente occupato dal
sistema stradale della via Cassia - Clodia e della
via Trionfale. Questo, se pur marginale all'area
del parco regionale, rappresenta la più rilevante
emergenza morfologica e storica dell'intero
comparto territoriale cui fa riscontro, sul
versante volto alla valle del Tevere, il sistema
della via Flaminia e Tiberina su percorrenze di
fondo valle e di controcrinale. Nella stessa
direzione dei citati sistemi viari si pone anche
l'antico asse stradale della via Veientana ancora
perfettamente riconoscibile nel suo percorso
punteggiato da presenze monumentali di tumuli e
sepolcri antichi. Un ulteriore asse viario antico,
trasversale ai precedenti, completa l'innervatura
terrioriale congiungendo la zona di Veio ed Isola
Farnese alla Domus culta Capracorum presso Santa
Cornelia ed alla valle del Tevere. Elementi di
grande interesse archeologico nell'area, oltre
all'abitato ed alle necropoli di Veio, sono alcune
grandi ville di epoca romana fra le quali la
notissima Villa di Livia "ad gallinas albas"
presso Prima Porta e la Villa di Lucio Vero presso
Villa Manzoni sulla Cassia. Ad altre anonime
strutture insediative disseminate in diverse zone
del Parco si possono aggiungere altri monumenti
celebri come il sepolcro dei Nasoni e la tomba
Celsa, lungo la via Flaminia, il sepolcro dei
Veienti sull'omonima strada, il sepolcro di C.
Vibio Mariano sulla via Cassia, da cui discende il
locale toponimo di "Tomba di Nerone",
l'arco di Malborghetto nell'omonima strada sulla
via Flaminia. In epoca medioevale e
rinascimentale, oltre alla vetusta domuculta
Capracorum , si ricordano gli insediamenti di
Isola Farnese, di Torre Vergara, della Crescenza,
della Storta e della Giustiniana oltre ad una
serie di strutture minori di difesa o di
sfruttamento agricolo del territorio (torri,
casali, mulini etc.) lungo le principali
direttrici viarie già indicate. L'articolazione
del territorio riflette ancora il relativo
frazionamento in vigne, nella parte più vicina
alla città, ed in grandi tenute, nelle zone più
periferiche; a queste ultime fanno riferimento
ancora gli antichi casali del Fosso, del Pino, dei
Tre Archi, di Santa Cornelia, della Vacchereccia,
di Buon Ricovero, di Tor Vergara, della
Spizzichina, di Ospedaletto Annunziata, della
Crescenza, di Monte Oliviero, della Valchetta, di
Prima Porta e di Malborghetto.
|
|
ARRONE CASTEL
DI GUIDO
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il comprensorio individuato costituisce solo parte
del Parco denominato Arrone - Castel di Guido dal
Sistema del "Piano Regionale dei Parchi e
delle Riserve Naturali" in quanto la zona sud
della Valle dell'Arrone, l'area di Macchiagrande
di Galeria e della tenuta di Castel di Guido, è
stata stralciata dall'ambito regionale proposto
perché recentemente inserita all'interno della
Riserva del Litorale romano, e parte del
territorio ad ovest dell'Arrone ricade all'interno
del territorio del Comune di Fiumicino.
 Aspetti geomorfologicii:
Aspetti geomorfologicii:
L'area è caratterizzata da tipico aspetto
collinoso della Campagna romana e rappresenta la
fascia di transizione alla pianura costiera.
L'altitudine media è compresa tra i 60 e i 70 m.
s.l.m., sono assenti i depositi vulcanici del
Pleistocene: stratigraficamente un singolo strato
di tufo (tufite) poggia su di uno strato argilloso
che sovrasta potenti strati sabbiosi di materiale
incoerente; sopra lo strato tufaceo si trovano gli
strati argillosi intercalati dagli strati sabbiosi
e da materiali piuttosto coerenti a matrice
pomicea. Sono presenti inoltre conglomerati
poligenici, argille e calcareniti di ambiente
marino contenente molluschi e foraminiferi
bentonici e planctonici.
Sono presenti nell'area il torrente Arrone la cui
sorgente lineare presenta una portata media
misurata di 500 m3/sec. ed il Fosso Galeria. La
rete idrica affluisce direttamente verso la
pianura costiera in direzione sud-ovest oppure
verso il Fosso Galeria.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
La copertura vegetazionale è costituita in
prevalenza da complessi arborei, arbustivi tipici
della macchia mediterranea e da boschi misti di
caducifoglie sempreverdi riferibili alla
formazioni planiziali costiere del litorale
laziale. I vari aspetti vegetazionali si
dispongono seguendo le diverse condizioni di
xericità e di umidità del suolo procedendo dalle
zone più elevate verso i bacini idrici. I
versanti delle vallecole, non coinvolte
nell'attività agricola, presentano uno strato
arboreo dominante a leccio (Quercus Ilex) con
qualche elemento di cerro (Quercus cerris) e
farnetto (Quercus frainetto) accanto a specie
caducifoglie: acero minore (Acer monspellanum),
acero campestre (Acer campestre), olmo (Ulmus
minor): Lo strato arbustivo è rappresentato da
pungitopo (Ruscus aculeatus) , fillirea (Phillyrea
latifolia), alaterno (Rhamnus alaternus). La
marcata antropizzazione causata dal taglio del
bosco , dal pascolamento e dagli incendi hanno
determinato la prevalenza di alcune specie
arbustive più resistenti ai fattori di disturbo
antropico: particolarmente abbondante la presenza
di sparzio villoso (Calicotome villosa)
sintomatica di un dinamismo della vegetazione
legato agli incendi. Le grandi superfici prative
dove viene esercitato il pascolo ovino sono
dominate da Brachipodium phoenicoides, graminacea,
spesso associata a finocchio selvatico (Foeniculum
vulgare) e carota (Daucus carota). Le rive del
fiume Arrone risultano prive della naturale
vegetazione ripariale e sporadicamente appaiono
individui di salice bianco (Salix alba) e ontano
comune (Alnus glutinosa).
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Rispetto ala notevole diversità ambientale ed ai
popolamenti potenziali, il territorio, da un punto
di vista faunistico, appare disturbato per l'alto
grado di antropizzazione. Di grande importanza per
le comunità faunistiche sono le zone boscate, i
pochi lembi di vegetazione dei versanti acclivi,
le siepi, i filari dove la fauna trova aree di
rifugio. Le aree aperte a prato-pascolo sono
territorio di caccia preferenziale del barbagianni
(Tyto alba) e della civetta (Athene noctua). Tra i
mammiferi sono presenti la donnola (Mustela
nivalis), il coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), l'istrice (Lepus europaeus), la faina
(Martes foina). L'area è interessata ad un vasto
passaggio dell'avifauna migratrice acquatica; vi
sono rappresentate le specie acquatiche e costiere
appartenenti, in grande maggioranza, alle
famiglie: Ardeidae (aironi), Anatidae (anatre),
Laridae (gabbiani), Podicipedidae (svassi). Tra
gli uccelli comuni troviamo: lo scricciolo (Troglotydes
troglotydes), il merlo (Turdus merola), la
capinera (Sylvia atricapilla) e il friguello (Fringilla
coelebs), l'allodola (Alauda arvensis), la
cornacchia grigia (Corvus corone cornix). Si
segnala inoltre la presenza del gruccione (Merops
apiaster), che nidifica con numerose colonie sulle
pareti sabbiose delle pendici collinari. Tra gli
anfibi troviamo il tritone punteggiato (Triturus
vulgaris) e tra i rettili la Biscia dal collare (Natrix
natrix) e la testuggine palustre (Emys orbicularis).
|
|
MARCIGLIANA
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il comprensorio individuato costituisce gran parte
del Parco della Marcigliana, che interessa area
ricadenti nei comuni di Guidonia e Mentana. L'area
è delimitata dalla via Salaria, dal confine
comunale verso il comune di Monterotondo, Mentana
e Guidonia, la via Nomentana, il G.R.A. e
l'autostrada Roma Firenze. L'area consta di un gruppo di alture delimitate ad
est dall'ampia pianura alluvionale del Tevere,
caratterizzata da brevi diramazioni del crinale
principale su cui scorre la via Nomentana.
L'area consta di un gruppo di alture delimitate ad
est dall'ampia pianura alluvionale del Tevere,
caratterizzata da brevi diramazioni del crinale
principale su cui scorre la via Nomentana.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
Area interessata dalle grandi tenute della
Marcigliana e di Tor S. Giovanni caratterizzate
dalle presenza di colline basse e arrotondate,
coltivate a seminativo estensivo o destinate a
pascolo e dalle vallecole con i versanti ricoperti
di vegetazione a macchia Sono presenti nell'area
affioramenti di depositi piroclastici incoerenti
dovuti all'attivita centrale e periferica del
Vulcano Sabatino
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
Le fitocenosi presenti nell'area sono costituite
prevalentemente da querceto misto laziale che
assume carattere più termofilo con la presenza di
roverella e cerro nelle zone più alte ed
assolate, mentre nelle parti più umide e fresche,
risulta caratterizzato dalla presenza della farnia
e del farnetto.
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Tra i mammiferi è da rilevare la presenza della
lepre italica, specie originariamente autoctona
della campagna romana, con la sottospecie L. L.
corsicanus, ormai quasi sicuramente estinta a
causa dell'inquinamento genetico causato dai
continui ripopolamenti con individui provenienti
dall'europa orientale e dal sud america. tra gli
uccelli, analogo discorso si può fare per la
starna italica, in quanto anch'essa di interesse
venatorio.
 Preesistenze storiche:
Preesistenze storiche:
Ruderi di ville romane e torri medievali (Tor S.
Giovanni); presenza di casali medievali e moderni,
in particolare il Casale della Marcigliana ( XVI
sec.) edificato sull'impianto di una villa romana.
|
|
TENUTA DEI
MASSIMI
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il comprensorio del Parco della Tenuta dei
Massimi, posto nel settore sud-ovest della città
in prosimità del G.R.A. ed ai margini del
territorio urbanizzato, è un'area di elevato
valore naturalistico e paesaggistico. L'area è
delimitata a nord da via della Vignaccia e via
della Pisana, ad ovest dal G.R.A., a sud dal
Tevere e ad est dall'edificato di Bravetta,
Corviale e Pino Lecce. La sua caratteristica
principale è la bellezza di un paesaggio agrario,
che alterna coltivi e pascoli a boschi a querce,
rimasto pressoché intatto se non in alcune zone
poste ai margini del Parco come alcune aree lungo
il fosso della Maglianella o in prossimità della
Torretta dei Massimi inclusa con l'antico casale
in un'area a giardino in cui sono andati
completamente perduti i caratteri del paesaggio
originario. La collocazione del Parco in prossimità
del comprensorio della Valle dei Casali con cui
realizza un continuum naturalistico rinforza la
funzione di corridoio di verde che la Valle e le
ville storiche numerose nel settore sud-ovest
della città realizzano collegando il centro
urbanizzato con la pianura alluvionale del Tevere
e le pianure costiere.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
L'area risulta morfologicamente articolata con
delle alture che raggiungono i 60m. s.l.m. e
costituiscono parte del più vasto altopiano che
caratterizza tutta la Valle dei Casali e che
degrada, a sud, verso la piana del Tevere:
L'articolazione delle alture risulta dovuta
all'azione erosiva del Tevere e dei affluenti
sulle antiche sabbie e ghiaie di origine marina e
fluviale ricoperte dei depositi vulcanici , mentre
ai depositi alluvionali è dovuta la progressiva
formazione delle fasce piane presenti per lo più
lungo i corsi d'acqua.
L'area è delimitata dai tratti dei corsi d'acqua
del Fosso di Brava, del Fosso di Acquafredda, del
Fosso di Bravetta e del Fosso della Maglianella.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
La localizzazione dell'area a ridosso del G.R.A.
risulta particolarmente strategica per garantire
un continuum naturalistico con le aree verdi della
Valle dei Casali che a loro volta rappresentano un
corridoio naturalistico a sud-ovest della città
tra la piana alluvionale del Tevere , le vaste
aree costiere ad ovest del G.R.A e le aree urbane.
Attualmente l'area risulta in parte adibita a
coltivi. L'uso agricolo si estende anche nei
territori limitrofi i corsi d'acqua che risultano
privi della naturale vegetazione ripariale arborea
mentre sono presenti formazioni a canna comune (Arundo
donax) di origine artificiale. Sulle estese zone
della sommità dei pianori sono presenti comunità
vegetali caratterizzate da tornasole comune (Chrozophora
Tinctoria), pianta ispida della famiglia delle
Euphorbiaceae simile all' ortica propria degli
incolti e da eliotropio selvatico (Heliotropium
europaeum); mentre sulle aree dei pendii non
adibite a coltura prevalgono incolti con specie di
graminacee proprie delle colture abbandonate e dei
pascoli aridi come Brachypodium Phoenicoides.
Alcune zone non coltivate limitrofe l'urbanizzato
risultano parzialmente degradate. Di particolare
interesse sono le aree boscate che caratterizzano
l'area e che si sviluppano sui versanti dei pendii
e in parte sulla sommità delle alture, esse sono
rappresentate da estensioni di consorzi compatti
di vegetazione seminaturale costituita
prevalentemente dalla associazione vegetale
Lathyro-Quercetum Cerris, comunità di cerro e
cicerchia (leguminosa), nelle quali sono presenti
elementi di sughera (Quercus suber). Tali consorzi
sono di notevole rilevanza ambientale
rappresentando nell'area della Valle dei Casali e
nel più vasto ambito periurbano a sud-ovest della
città, nuclei di collegamento naturalistici
relativamente ai diversi parametri ecologici,
vegetazionali e faunistici.
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
La fauna dell'area rispecchia quella tipica dei
sistemi agricoli adiacenti : tra i roditori
troviamo il topo selvatico (Apodemus sylvaticus),
l'arvicola di Savi (Microtus Savi), il ratto nero
( Rattus rattus) ed il topolino delle case (Mus
domesticus). Tra gli uccelli presenti il gheppio
(Falco tinnanculus) ed il nibbio bruno (Milvus
migrans), diversi sono i passeriformi tra i quali
il santimpalo (Saxicola torquata); lo storno (Sturnus
vulgaris), il cardellino (Carduelis carduelis),
l'allodola (Alauda arvensis). Nelle aree boscate
sono inoltre presenti l'allocco (Strix aluco), il
torcicollo (Jynx torquilla) ed il picchio rosso
maggiore (Picoides maior).
|
|
MONTE MARIO
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il Parco di Monte Mario, costituito dal sistema
geomorfologico dei Colli della Farnesina, si
estende su una superficie di circa 190 ha sulla
destra orografica del Tevere nel quadrante
nord-ovest della città, all'interno del contesto
fortemente urbanizzato dei quartieri Prati,
Trionfale, Delle Vittorie, Monte Mario, Balduina,
Trionfale e Camilluccia ed in contiguità alle
attrezzature sportive del Foro Italico.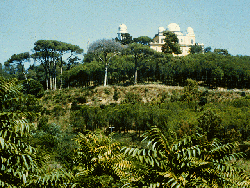 Esso è delimitato a nord da Via dei Colli della
Farnesina, ad est dalla Via Olimpica, a sud da
Piazzale Clodio, Via Trionfale, Circonvallazione
Trionfale e ad est in successione da Via Fedro,
Via Cadlolo, Via Tionfale e Via della Camilluccia.
In base all'art. 2 della legge regionale del 17
luglio 1989 n.46, che inseriva la realizzazione
del Parco di Monte Mario ed il recupero di Villa
Mazzanti tra i programmi per i Mondiali di Calcio
del 1990 con l'intenzione di realizzare un'opera
che, oltre alla funzione di verde pubblico
fruibile, avesse le valenze di compensazione
ambientale per il settore urbano che maggiormente
avrebbe subito l'impatto delle opere per i
mondiali, sono già stati attuati gran parte degli
interventi previsti da un progetto esecutivo che
interessava prevalentemente le aree di proprietà
pubblica ed aree di cui si proponeva
l'acquisizione o la cessione, e riguardavano la
vegetazione, le opere di regimazione delle acque
superficiali ed il mantenimento dei pendii, la
realizzazione dei percorsi e di aree attrezzate.
Esso è delimitato a nord da Via dei Colli della
Farnesina, ad est dalla Via Olimpica, a sud da
Piazzale Clodio, Via Trionfale, Circonvallazione
Trionfale e ad est in successione da Via Fedro,
Via Cadlolo, Via Tionfale e Via della Camilluccia.
In base all'art. 2 della legge regionale del 17
luglio 1989 n.46, che inseriva la realizzazione
del Parco di Monte Mario ed il recupero di Villa
Mazzanti tra i programmi per i Mondiali di Calcio
del 1990 con l'intenzione di realizzare un'opera
che, oltre alla funzione di verde pubblico
fruibile, avesse le valenze di compensazione
ambientale per il settore urbano che maggiormente
avrebbe subito l'impatto delle opere per i
mondiali, sono già stati attuati gran parte degli
interventi previsti da un progetto esecutivo che
interessava prevalentemente le aree di proprietà
pubblica ed aree di cui si proponeva
l'acquisizione o la cessione, e riguardavano la
vegetazione, le opere di regimazione delle acque
superficiali ed il mantenimento dei pendii, la
realizzazione dei percorsi e di aree attrezzate.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
Il rilievo di Monte Mario , che raggiunge i 139 m.
s.l.m., risulta il più imponente del sistema dei
colli denominati Monti della Farnesina che
superano di poco i 100/120 m. s.l.m. e che si
dispongono successivamente in direzione sud-nord.
L'intero territorio è geologicamente riferibile
al complesso sabbioso-ghiaioso pleistocenico, ma i
terreni più antichi che costituiscono a diverse
profondità il basamento comune per tutta l'area
romana sono le argille plioceniche, depositatesi
4. milioni di anni fa di anni fa, i movimenti
tettonici intercorsi hanno successivamente
provocato, lungo la dorsale che da Monte Mario
raggiunge il Gianicolo e Monteverde, il loro
sollevamento ad occidente de Tevere fin da
affiorare in superficie ed essere visibili in
particolare sul rilievo di Monte Mario. Alle
pendici di Monte Mario, al di sopra di queste
argille dal caratteristico colore azzurro è
visibile il passaggio alle ghiaie e sabbie gialle
della età pleistocenica che tra l'altro
costituiscono la cima di tutti i rilievi della
riva destra del Tevere: si tratta di sedimenti di
mare poco profondo noti per l'abbondanza della
malacofauna in esse contenute.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
I consorzi vegetazionali presenti rispondono in
gran parte alle caratteristiche mesofite della
vegetazione mediterranea sempreverde da cui si
distaccano elementi e spesso vere cenosi
mesoigrofile che si sviluppano in risposta a
particolari condizioni microclimatiche più umide
presenti lungo i versanti settentrionali dei colli
e soprattutto nelle strette e profonde vallette
interposte tra i colli stessi : qui infatti il
microambiente assume quasi condizioni submontane
con larga partecipazione di elementi non solo
della fascia a roverella (Quercus pubescens)
carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus
ornus) , ma anche della fascia a Quercus, Tilia,
Acer, con la presenza di nocciolo (Corylus
avellana), ligustro(Ligustrum vulgare), corniolo (Cornus
sanguinea). Le componenti mediterranee con
elementi mesofili risultano comunque le più
copiose e rigogliose. Tali consorzi che rispondono
ad una vegetazione mediterranea sempreverde con
leccio (Quercus ilex), sughera (Q. suber), cisto (Cistus
salvifolius). Ove il carattere di mesofilia si
attenua passando ad esempio dai versanti orientali
a quelli occidentali i consorzi si arricchiscono
delle specie mediterranee proprie quali: fillirea
(Phillyrea latifolia), alaterno (Rhamnus alaternus),
ginestra (Spartium junceum), mirto (Myrtus
communis) e asparago (Asparagus acutifolius). In
condizioni più xerofile persistono le sclerofille
mediterranee più adatte a simile ambiente quali
lentisco (Pistacia lentiscus) e cisto (Cistus
salvifolius). Lungo i pendii assolati sottoposti a
taglio o incendi sono riscontrabili estensioni,
anche monofitiche, di ginestra (Spartium junceum).
Significativa nelle zone più umide è la presenza
di canna comune (Arundo donax) mentre nei
fondovalle e nelle aree di impluvio sono presenti
elementi di pioppo bianco (Populus alba) e salice
bianco (Salix alba). Il forte antropismo e le
azioni di taglio e di riporto di terra nonchè gli
incendi hanno favorito condizioni per
l'insediamento di popolazioni di falsa acacia
(Robinia pseudoacacia) presente in considerevoli
estensioni, ed ailanto (Alianthus glandulosa) ,.
Sambuco (Sambucus sp) e clemantide (Clemantis
vitalba).
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Il notevole grado di antropizzazione risulta una
componente di disturbo per le popolazioni
faunistiche dell'area. Le specie presenti sono
riconducibili ad una fauna urbana alterata nei
parametri ecologici; presenti tra i roditori il
moscardino (Muscardinus avellanarius), il topolino
delle case (Mus musculus), il topo selvatico (Apodemus
sylvaticus), il ratto nero (Rattus rattus). Tra i
rettili presenti i sauri con le specie lucertola
muraiola (Podarcis muralis), lucertola campestre (Podarcis
sicula). Tra l'avifauna notevoli le presenze
appartenenti all'ordine dei passeriformi quali il
pettirosso (Erithacus rubecola), il merlo (Turdus
Merula), il codibugnolo (Aegithalos caudatus), il
verdone (Carduelis Chloris), il cardellino (Carduelis
carduelis). Presenti inoltre a ridosso delle zone
edificate la taccola (Corvus monedula) e lo storno
(Sturnus vulgaris).
|
|
VALLE DELL'ANIENE
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il comprensorio individuato costituisce solo parte
del Parco denominato Valle dell'Aniene dal Sistema
del "Piano Regionale dei Parchi e delle
Riserve Naturali" in quanto tale parco si
estende anche in comuni limitrofi. In particolare il parco della Valle dell'Aniene si
estende lungo il corso dell'Aniene, attingendo
"aree libere" in riva destra ed in riva
sinistra; ampliamenti di questo parco
"lineare" si riscontrano in
corrispondenza del Parco di Tor Sapienza,
dell'area di protezione delle falde idriche
dell'Acquedotto dell'Acqua Vegine e dell'intera
area occupata dall'antico lago di Castiglione fino
a San Vittorino.
In particolare il parco della Valle dell'Aniene si
estende lungo il corso dell'Aniene, attingendo
"aree libere" in riva destra ed in riva
sinistra; ampliamenti di questo parco
"lineare" si riscontrano in
corrispondenza del Parco di Tor Sapienza,
dell'area di protezione delle falde idriche
dell'Acquedotto dell'Acqua Vegine e dell'intera
area occupata dall'antico lago di Castiglione fino
a San Vittorino.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
Area caratterizzata, nel tratto urbano, dalle
numerose anse del fiume Aniene nella fase di
immissione nel Tevere; nel tratto extraurbano
predomina l'aspetto morfologico tipico della
campagna romana caratterizzato dalla presenza di
elementi morfologici di grande interesse quale le
sorgenti dell'Acqua Vergine, le latomie di
Salone,il cratere dell'antico lago di castiglione
e l'area di Pantano borghese.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
La morfologia prevalentemente pianeggiante del
territorio ha favorito l'istaurarsi di un bosco a
carattere mesofilo nel quale prevalgono farnia,
cerro e farnetto e che nei pressi dell'alveo
fluviale assume l'aspetto di fitocenosi ripariale
alla quale si aggiungono elementi che usualmente
costituiscono il bosco a caducifoglie quali il
cerro, l'olmo, il frassino e l'acero; si viene così
ad istaurare, in tale contesto, un'interessante
articolazione tra popolamenti appartenenti ai
Quercetalia pubescentis con la prevalenza del
Farnetto e quelli dell'Ostryo carpinion orientalis
nelle zone più drenate. Da rilevare una discreta
presenza di elementi della lecceta dove il suolo
si arricchisce di carbonati nei settori più
estremi della valle.
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Da segnalare la presenza del gambero di fiume e
del granchio di fiume che costituiscono due
indicatori ecologici molto validi; tale
comprensorio inoltre potrebbe costituire
l'ambiente idoneo per la reintroduzione della
lontra che era presente fino a pochi anni fa.
 Preesistenze storiche:
Preesistenze storiche:
L'area è attraversata da tracciati romani,
presenza di necropoli, ville etrusche, Area
archeologica di Gabii, resti monumentali di
acquedotti ; numerosi casali antichi e moderni,
castello di Lunghezza e di Corcolle.
|
|
DECIMA
MALAFEDE
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il comprensorio individuato si estende tra il
G.R.A., la via Pontina, la Tenuta Presidenziale di
Castel Porziano, il confine Comunale verso Pomezia
e la via Laurentina. E' un territorio omogeneo,
caratterizzato da aspetti naturalistici tipici
della prima dorsale collinare che si oppone alla
fascia litoranea; data la presenza di alcune
grandi tenute agricole l'aspetto è quello tipico
della campagna romana. Di notevole interesse, data
la importante funzione storica dell'area, alcune
emergenze archeologiche ed alcuni casali e
complessi fortificati.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
Area segnata in particolare dal fosso di Malafede
che la attraversa seguendo l'asse NO-SE, e dalle
sue ramificazioni; presenza di altri fossi (F. di
Perna, F. della Mandriola, F. dei Radicelli, F.
della Selvotta e F.di Leva) che costituiscono un
sistema morfologico unitario. L'area è
caratterizzata dalla presenza di alcune tenute
agricole (Perna, Selcetta, Penseroni, Mandriola e
Trigoria)
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
Sono presenti, in ambiti molto vicini, fitocenosi
diverse, da quelle più tipicamente mediterranee
appartenenti alla serie dinamica della lecceta,
comprensiva della variante a sughera, fino al
bosco più mesofilo a farnetto con i suoi stadi di
degrado. Nelle zone soggette a frequenti
inondazioni sono stati rilevati residui di
boscaglie igrofile a pioppo, salice e frassino.
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Rilevante risulta la presenza della lepre italica,
mentre sembrerebbero presenti la martora ed il
gatto selvatico anche se mancano segnalazioni
recenti; lo stesso discorso è valido per quanto
riguarda la starna italica. Infine sono state
rilevate due specie di testuggine molto
vulnerabili, la testuggine palustre e la
testuggine di Hermann.
 Preesistenze storiche:
Preesistenze storiche:
Area archeologica di castel di decima, Castello e
torre di monte di Leva, area della solforata e
della grotta di Fauno; ruderi di ville romane e di
torri medievali; casali moderni
|
|
PARCO DI
AGUZZANO
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
La natura geologica del parco di aguzzano è
legata agli ultimi prodotti della seconda fase
parossistica del vulcano Laziale e più
precisamente al complesso dei " tufi
inferiori" rappresentati dalle pozzolane
grigie superiori e dal tufo lionato.
Le pozzolane grigie superiori affiorano nel
settore meridionale dell'area e sovrastano
l'orizzonte litoide detto "tufo lionato",
anch'esso affiorante nella zona meridionale del
parco, a quote relativamente più elevate, dal
fondovalle e dal fosso di S.Basilio; lungo
quest'ultimo affiorano invece le alluvioni recenti
derivate dallo smantellamento dei materiali
piroclastici presenti nell'area e in zone
limitrofe.
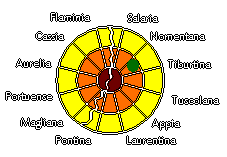 Per quanto riguarda l'attuale aspetto morfologico
del territorio, esso è il risultato della
combinazione ed interazione di tali fattori, quali
gli agenti degradatori naturali e di origine
antropica, le caratteristiche geologiche e il
clima.
Per quanto riguarda l'attuale aspetto morfologico
del territorio, esso è il risultato della
combinazione ed interazione di tali fattori, quali
gli agenti degradatori naturali e di origine
antropica, le caratteristiche geologiche e il
clima.
Il motivo morfologico dominante dell'area,
compresa tra le quote di 19 m e 37 m s.l.m., è il
Fosso di S. Basilio con la sua relativa valle che
si presenta con pendii moderatamente acclivi; solo
in corrispondenza degli affioramenti tufacei si
notano piccole scarpate verticali.
Le sommità dei rilievi si mostrano sub-tabulari,
e il fondovalle è piatto; ciò è dovuto alle
caratteristiche genetiche e alle modalità
posizionali delle colate piroclastiche che hanno
provveduto, in varie successioni, a livellare le
morfologie preesistenti.
Il fenomeno geomorfologico prevalente è
l'erosione diffusa legata all'azione delle acque
meteoriche e selvagge; questa assume caratteri di
particolare intensità, con modificazioni
relativamente repentine delle forme superficiali.
Nel fondovalle del Fosso di S. Basilio sono
prevalsi invece fenomeni di accumulo legati alla
sedimentazione del suddetto fosso che attualmente
si può considerare come un canale di raccolta di
acque reflue e spesso stagnanti; inoltre il corso
del fosso è stato modificato dall'uomo in più
punti perdendo totalmente la funzione naturale che
gli competeva.
Nonostante la morfologia sia caratterizzata da
leggeri rilievi in corrispondenza dei tufi e delle
pozzolane e da un andamento sub-pianeggiante in
corrispondenza della coltre alluvionale solcata da
un fosso con andamento NE-SW lungo il quale si
raggiungono le quote minime s.l.m. dell'area del
parco, la superficie piezometrica risulta
deprimersi verso sud-ovest al di sotto dei rilevi
formati da piroclastiti, mentre presenta un
massimo in corrispondenza del solco idrografico.
La falda acquifera è localizzata in terreni
sabbiosi-sabbiolimosi di origine fluviolacustre, a
luoghi sormontati da un esiguo spessore di
materiale vulcanico sciolto e rimaneggiato,
originato dallo smantellamento delle piroclastiti
in situ.
Per quanto riguarda il clima, l'area è
interessata da una piovosità media annua,
rilevata dagli Annali del Servizio Idrografico(
stazione pluviometrica di Settecamini), pari a
circa 970 mm di pioggia con un minimo
pluviometrico e termico rispettivamente nei mesi
di ottobre-novembre ed agosto.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
Il territorio del Parco, utilizzato a fini
agricoli sin dal Seicento, presenta impianti
arborei realizzati dall'uomo in relazione a tale
uso specifico e conserva ancora oggi alcune
caratteristiche della Campagna Romana del secolo
scorso.
L'impianto a verde esistente è legato alla
presenza dei tanti piccoli fossi seminaturali
utilizzati per l'irrigazione dei terreni: l'area
risulta infatti caratterizzata da prato pascolo,
che ricopre l'intera superficie, e da un
reticolato di filari di alberi di alto fusto, con
qualche raro episodio di vegetazione arbustiva,
che rappresentano uno dei segni più
caratteristici del parco.
Il prato pascolo, presente per oltre l'80%
dell'intera superficie del parco, è costituito da
vegetazione erbacea mantenuta molto bassa dal
pascolo intensamente esercitato; soltanto nel
settore orientale, a ridosso di via del casale di
S.Basilio, il tappeto erboso diventa sensibilmente
più alto (circa 60 metri).
Dal punto di vista floristico sono state rilevate
prevalentemente specie infestanti le colture quali
Daucus carota l., Malva sylvestris., Taraxacum
officinale Weber aggr., e specie ruderali e
nitrofile quali Urtica dioica l. Linaria vulgaris
Miller.
Elementi caratteristici del parco sono i filari di
alberi di alto fusto posti lungo i viali e spesso
lungo i fossi precedentemente citati. Queste
alberature definivano utilizzazioni agricole
differenti e alcune di esse seguono ancora oggi i
confini delle antiche tenute agricole di Aguzzano,
Aguzzanello e Podere S.Antonio.
Lungo i viali principali si possono individuare
doppi filari a pino domestico (Pinus pinea L.) nei
quali gli esemplari sono posti a una distanza di
15 metri l'uno dall'altro ed in alcuni casi sono
alternati ad arbusti di oleandro (Nerium oleander
L.); gli esemplari di pino domestico presentano un
diametro di cm.50 in media ed un'età presunta di
100-150 anni.
Saltuariamente, lungo i filari di pini, si possono
individuare singoli esemplari di eucalipto (Eucaliptus
rostrata Schelcht) di dimensioni notevoli
(cm.90-100 di diametro), alcuni dei quali
purtroppo completamente secchi.
Lungo il Fosso di San Basilio, nella parte più
bassa del suo corso, appare con evidenza un doppio
filare di pioppi (Populus canadensis L.) trattati
a "ceppaia", che si sviluppa in altezza
per 10-15 metri; la distanza tra le piante varia
da 2 a 4 metri.
Questo doppio filare risulta interrotto per lunghi
tratti, specialmente nella parte superiore del
fosso nel settore orientale del Parco.
I filari di platano (Platanus occidentalis L.)
costituiscono un altro elemento che compone il
reticolo di alberature presente nel Parco.
Di questi filari, che un tempo dovevano essere più
numerosi, solo alcuni sono completi di tutti gli
elementi, mentre molti altri sono individuabili
dall'allineamento di esemplari residui. Anche i
platani sono trattati a ceppaia con un fusto molto
breve (circa un metro e mezzo) che si ramifica in
4-6 branche e mediamente non supera i 10 metri di
altezza; i singoli esemplari sono stati messi a
dimora aduna distanza variabile da 2 a 4 metri.
Talvolta, insieme ai filari di platano, o a ciò
che rimane, è possibile individuare alcuni
esemplari di noce (Juglans regia L..).
Altre alberature , costituite in prevalenza da
essenze della stessa specie come, pini, platani e
cipressi (Cupressus sempervirens L.) sono presenti
intorno ai numerosi casali del parco.
Nei pressi del casale posto al margine sud sono
presenti alcuni esemplari di olivo (Olea europea
L.) che probabilmente costituiscono i resti di un
impianto di dimensioni maggiori.
Alcuni ambienti seminaturali sono presenti lungo
le sponde dei fossi, ove, insieme a pioppi e
platani, sono stati rilevati esemplari di salice (Salix
alba L..) anche di notevoli dimensioni (15 metri
circa) e di robinia (Robinia pseudoacacia L.)
specie esotica avventizia; un ambiente simile è
presente anche nella zona a nord-ovest dell'area.
Un altro microambiente seminaturale rilevato
all'interno del Parco è quello costituito ad
ovest da una scarpata non molto alta (circa 3
metri) a pianta semicircolare che termina a nord
con un dislivello più accentuato (7-8 metri
circa) ove è visibile la stratificazione delle
rocce superficiali tufacee. Sulla scarpata sono
presenti pioppi canadesi che qui però hanno un
portamento diverso da quelli posti lungo il Fosso
di San Basilio trattati a "ceppaia".
Inoltre sono presenti olmi (Ulmus minor Miller) in
forma arbustiva, rovi (Rubus ulmifolius Schott),
fichi (Ficus carica L.), arbusti di sambuco (Sambucus
nigra L.) e alberi da frutto del genere Prunus.
Nella parte terminale della scarpata il dislivello
è più accentuato, molto probabilmente a causa di
una forma di erosione dovuta alla presenza di
acqua negli strati superficiali del terreno;
infatti in questa zona sono state rilevate specie
che crescono su terreni molto umidi come canne
domestiche (Arundo donax L.), ebbio (Samucus
ebulus L.) e menta (Mentha pulegium L.).
 Aspetti faunistici:
Aspetti faunistici:
Le ridotte dimensioni dell'area, la sua inclusione
all'interno di un territorio densamente edificato,
la prevalente caratterizzazione vegetazionale a
prato-pascolo, fanno del Parco di Aguzzano un
unico biotipo frequentato da una fauna non molto
ricca e poco diversificata, propria dei pascoli e
dei prati cittadini.
Tra gli anfibi censiti di particolare rilevanza
appare la presenza del Rospo smeraldino.
Per quanto riguarda gli uccelli, è stata rilevata
la presenza di 30 specie nidificanti; interessante
è la presenza del Gheppio,che utilizza il Parco
quale territorio di caccia, e di alcune specie di
uccelli insettivori quali il Saltimpalo, il
Torcicollo e lo Strillozzo. Lungo il fosso di San
Basilio è stata inoltre rilevata la presenza
della Gallinella d'acqua.
Tra i mammiferi sono presenti alcune specie di
predatori come la Volpe e la Donnola.
Infine tra i rettili appare ancora di un certo
interesse la presenza del Biacco e della Biscia
dal collare.
|
|
PINETO
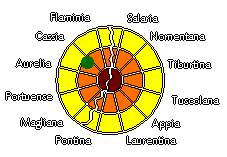
 Ubicazione e perimetro:
Ubicazione e perimetro:
Il Parco del Pineto, che si estende per una
superficie di 250 ha. nel settore nord-occidentale
della città, è delimitato a nord dalla via
Trionfale, ad ovest dalla via della Pineta
Sacchetti, a sud dal quartiere di Valle Aurelia ad
est dalla Ferrovia Roma-Nord; la parte orientale
è attraversata longitudinalmente, in direzione
Nord-Sud, dalla sede del nuovo anello ferroviario
urbano.
Sotto l'aspetto orografico il territorio del Parco
è costituito da una vallata profondamente incisa
da fenomeni di erosione, denominata Valle
dell'Inferno, che si estende dalle propaggini
occidentali delle colline di Monte Mario a quelle
settentrionali del Vaticano; esso fa parte di un
più vasto sistema ambientale, un tempo omogeneo e
continuo, che partendo dalla valle della
Insugherata arriva fino a via della Pisana
includendo anche Villa Pamphili e le aree verdi
ancora edificate.
 Aspetti geomorfologici:
Aspetti geomorfologici:
Il territorio del Parco del Pineto occupa una
lunga e stretta striscia di terreno ad andamento
meridiano; esposto principalmente ai venti N-W, è
compreso fra le quote di circa 120 e 35 metri
s.l.m., con il minimo lungo il margine meridionale
ed il massimo a nord in prossimità Via Trionfale.
La piovosità media annua, rilevata nella Stazione
Pluviometrica di Roma M.Mario (+110 m. s.l.m.) è
pari a circa 892 mm. di pioggia.
Il minimo pluviometrico e termico è stato
riscontrato rispettivamente nei mesi di luglio e
gennaio ed il massimo pluviometrico e termico nei
mesi rispettivamente di ottobre ed agosto. L'area
presenta vaste zone ricoperte da una coltre
piroclastica e profondamente intagliate
dall'erosione lineare e diffusa delle acque
meteoriche e di quelle incanalate. Le valli
risultano incassate con pendii piuttosto acclivi e
pareti verticali in corrispondenza dei principali
affioramenti tufacei, mentre le sommità dei
rilievi sono pianeggianti.
Il fenomeno geomorfologico prevalente è
l'erosione fluviodenudazionale, legata all'azione
delle acque meteoriche selvagge ed incanalate, che
assume frequentemente caratteri di particolare
intensità, provocando rapide variazioni delle
forme superficiali. Quando l'erosione si verifica
su colate piroclastiche, il tratto di versante
corrispondente, assume una pendenza prossima alla
verticale.
 Aspetti botanici:
Aspetti botanici:
L'area del Parco del Pineto, ritenuta una delle più
belle plaghe botaniche della città, è costituita
da un vasto complesso vegetazionale. La
compresenza di sabbie ed argille crea situazioni
molto differenti nell'umidità del terreno e
quindi nella vegetazione, facendo sì che
nell'area, relativamente ristretta, convivano
biocenosi che possiedono caratteristiche
ecologiche differenti. L'inclinazione dello strato
delle argille marnose impermeabili (che scende
verso est) ed il suo affioramento sulle mezze
coste collinari, determinano inoltre risorgenze
acquee ed in alcune zone ristagni, che spiegano il
dimorfismo delle fitocenosi presenti.
La Valle dell'Inferno è ricoperta, soprattutto
nella zona Nord e in quella centrale, da
popolamenti boschivi costituiti da uno strato
arboreo alto 10-12 m., da uno strato arbustivo
alto circa 5m., da un secondo strato arbustivo di
circa 1 m. e da uno strato erbaceo di 50-70 cm.
Tra i popolamenti boschivi sempreverdi il Quercus
suber rappresenta l'essenza dominante; l'albero
raggiunge i 12 m. di altezza ed ha un diametro di
40 cm. Si tratta di boschi di sugherete di
dimensioni ridotte rispetto al passato e di cui
abbiamo traccia in alcuni documenti del XVII
secolo relativi alla "Tenuta del Pigneto".
Sono inoltre presenti popolamenti boschivi
caducifogli come il Quercus pubescens, il Quercus
frainetto, il Quercus robur, il Corylus avellana,
il Fraxinus ornus, cui si aggiungono diversi
raggruppamenti arbustivi dove domina il Cistus
salvifolius e l'Erica arborea.
Il bioclima relativo alla zona in esame non mostra
differenze significative rispetto ad altre aree
romane per quanto riguarda i valori medi delle
temperature.
La vegetazione presente è di particolare
interesse poiché costituisce un esempio
riepilogativo della vegetazione del basso Lazio
tirrenico, dalle dune litoranee alle stazioni
pedemontane.
Tale interesse si riferisce in particolare:
- alla presenza di
popolamenti boschivi a Quercus suber, che
costituiscono un esempio di vegetazione
costiera posta a circa 22 km. dal mare e che
sono considerati alcuni tra i lembi residui
degli antichi boschi sub-costieri che un tempo
occupavano la costa tirrenica. La Sughereta
della Valle dell'Inferno rappresenta una parte
significativa di quella più vasta che si
estendeva nella zona N-W di Roma e comprendeva
le zone della Pisana, di Brava, di Casetta
Mattei e dell'Insugherata.
- alla compresenza in un
ambiente relativamente ristretto (250 ha.) di
specie vegetali con esigenze ecologiche
differenti; nella valle si trovano a convivere
elementi mesofili (Quercus frainetto, Corylus
avellana, ecc.) con elementi termofili e
xerofili (Quercus pubescens, Erica arborea,
ecc.). Infatti accanto agli episodi di
vegetazione costiera possiamo trovare delle
fitocenosi più mesofile che rappresentano un
preludio dei boschi sud-montani che ricoprono
i rilievi ad ovest di Roma fino alle pendici
della catena appenninica; nelle zone di
fondovalle, che in alcuni periodi dell'anno
rimangono sommerse, sono presenti fitocenosi
idro-elofitiche. Si tratta in sostanza della
concentrazione entro uno spazio molto limitato
della caratteristica eterogeneità delle
cenosi laziali, soggette a sottoclimi diversi
e alle condizioni ecologiche più varie.
- alla ricchezza
floristica. Lo studioso Giuliano Montelucci
che negli anni '40 condusse uno studio sulla
flora e sulla vegetazione dell'intera Valle
dell'Inferno e durante il quale catalogò 681
essenze vegetali, propose fin dal 1954 di
proteggere la zona per farne un "parco
naturale".
Oggi a causa
dell'effetto antropico, questa ricchezza si è
ridotta; al suo impoverimento va aggiunto il
fenomeno di ampia ibridazione, di difficile
classificazione, che alcuni studiosi hanno
rivelato in quest'area. Le Querce caducifoglie
hanno dato luogo a numerosi ibridi (Quercus
pubescens x Quercus robur e Quercus pubescens x
Quercus frainetto, ecc.).
Occorre inoltre osservare che nella Valle
dell'Inferno era un tempo frequente il Quercus
ilex, oggi raro, probabilmente perché il leccio
in una stazione caldo umida, non riesce ad
ostacolare la conquista del terreno da parte della
sughera.
In una posizione isolata rispetto alla Valle,
precisamente nella parte S-W dell'area oggetto di
studio, si trova la "Pineta Sacchetti".
Il suo impianto fu realizzato dai Torlonia nel
1861 in un'area che nel XVII secolo era sistemata
in parte a vigna. La pineta non presenta un
particolare interesse botanico poiché il suo
sottobosco, compromesso dall'impatto antropico,
non esiste più.
Molte aree di questa valle coltivate a vigneto o
utilizzate per seminativi, negli anni '60-'70,
sono ormai abbandonate mentre rimane intensa
l'attività di pascolo.
I popolamenti boschivi presenti, così come sempre
accade negli ambienti naturali in zone
antropizzate, risultano danneggiati dal taglio
degli alberi, dagli incendi e dal pascolo, che ne
mettono in pericolo la sopravvivenza.
|
|


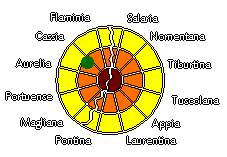 Per la sua collocazione l'area dell'Insugherata,
oltre a rappresentare un polmone verde
indispensabile per la città, insieme ai
comprensori del Pineto e di Veio tra cui si
inserisce come collegamento naturale, realizza un
cuneo di verde che dalle zone più centrali della
città si allarga in direzione nord ovest oltre i
confini delle aree urbanizzate. Morfologicamente
l'area dell'Insugherata si presenta molto
articolata e caratterizzata da estesi pianori su
modesti rilievi collinari tra cui è possibile
spaziare verso il sistema collinare a nord della
città, solcati da una serie di vallecole che
confluiscono nelle valli principali dell'Acqua
Traversa e dei suoi immissari fosso dell'Insugherata,
fosso della Rimessola e fosso dei Frati. Gli
elementi caratterizzanti di quest'area,
compromessa solo ai margini lungo le vie consolari
da intensi processi edificatori che non hanno
interessato le aree interne perché, ha differenza
di molte aree di proprietà privata, apparteneva
al patrimonio del Pio Istituto di S.Spirito ed
affittato per usi agricoli , sono la varietà e la
rarità in uno spazio limitato di paesaggi e
associazioni vegetali ancora prossimi allo stato
di naturalità e la presenza di specie poco
diffuse nella Regione come l'agrifoglio. Il
maggior pregio è dato dalla vegetazione di tipo
mediterranea, lembi residui di antiche foreste,
che ricoprono le pendici delle vallecole con
notevoli estensioni di sughere o si presentano in
bellissimi esemplari isolati di notevoli
dimensioni lasciati nei prati una volta a pascolo
a protezione delle greggi. Accanto a questa
vegetazione, amante del caldo e del terreno secco,
si trovano formazioni boschive di ambienti freschi
ed umidi. Coltivi o seminativi hanno sostituito
gli antichi pascoli nei pianori sulla sommità
delle collinette e nelle vallecole dove non
interessate da fitta vegetazione idrofila. Lungo
le consolari che seguono percorsi di crinale sono
distribuite notevoli emergenze archeologiche quali
resti di ville romane, sepolcri ed il tracciato
interrato dell'acquedotto Traiano -Paolo.
All'interno dell'area, che in parte corrispondeva
alla tenuta di "Inzuccherata", censita
al Catasto Alessandrino, si trovano inoltre resti
di una necropoli, numerose aree fittili nonchè
resti di una torre medioevale e dei casali
moderni. Le finalità da perseguire nella
realizzazione del Parco dell'Insugherata sono
volte a costituire un parco
naturalistico-archeologico che conviva con le
vocazioni agricole di parte del territorio. Sono
indirizzate pertanto al risanamento, alla tutela,
conservazione e valorizzazione dell'ambiente
naturalistico, al recupero e valorizzazione delle
emergenze archeologiche ed alla conservazione
delle vocazioni agricole del territorio.
Per la sua collocazione l'area dell'Insugherata,
oltre a rappresentare un polmone verde
indispensabile per la città, insieme ai
comprensori del Pineto e di Veio tra cui si
inserisce come collegamento naturale, realizza un
cuneo di verde che dalle zone più centrali della
città si allarga in direzione nord ovest oltre i
confini delle aree urbanizzate. Morfologicamente
l'area dell'Insugherata si presenta molto
articolata e caratterizzata da estesi pianori su
modesti rilievi collinari tra cui è possibile
spaziare verso il sistema collinare a nord della
città, solcati da una serie di vallecole che
confluiscono nelle valli principali dell'Acqua
Traversa e dei suoi immissari fosso dell'Insugherata,
fosso della Rimessola e fosso dei Frati. Gli
elementi caratterizzanti di quest'area,
compromessa solo ai margini lungo le vie consolari
da intensi processi edificatori che non hanno
interessato le aree interne perché, ha differenza
di molte aree di proprietà privata, apparteneva
al patrimonio del Pio Istituto di S.Spirito ed
affittato per usi agricoli , sono la varietà e la
rarità in uno spazio limitato di paesaggi e
associazioni vegetali ancora prossimi allo stato
di naturalità e la presenza di specie poco
diffuse nella Regione come l'agrifoglio. Il
maggior pregio è dato dalla vegetazione di tipo
mediterranea, lembi residui di antiche foreste,
che ricoprono le pendici delle vallecole con
notevoli estensioni di sughere o si presentano in
bellissimi esemplari isolati di notevoli
dimensioni lasciati nei prati una volta a pascolo
a protezione delle greggi. Accanto a questa
vegetazione, amante del caldo e del terreno secco,
si trovano formazioni boschive di ambienti freschi
ed umidi. Coltivi o seminativi hanno sostituito
gli antichi pascoli nei pianori sulla sommità
delle collinette e nelle vallecole dove non
interessate da fitta vegetazione idrofila. Lungo
le consolari che seguono percorsi di crinale sono
distribuite notevoli emergenze archeologiche quali
resti di ville romane, sepolcri ed il tracciato
interrato dell'acquedotto Traiano -Paolo.
All'interno dell'area, che in parte corrispondeva
alla tenuta di "Inzuccherata", censita
al Catasto Alessandrino, si trovano inoltre resti
di una necropoli, numerose aree fittili nonchè
resti di una torre medioevale e dei casali
moderni. Le finalità da perseguire nella
realizzazione del Parco dell'Insugherata sono
volte a costituire un parco
naturalistico-archeologico che conviva con le
vocazioni agricole di parte del territorio. Sono
indirizzate pertanto al risanamento, alla tutela,
conservazione e valorizzazione dell'ambiente
naturalistico, al recupero e valorizzazione delle
emergenze archeologiche ed alla conservazione
delle vocazioni agricole del territorio.
 Da un punto di vista topografico la valle si
estende per oltre 6 Km con direzione nord-sud da
Villa Panphyli e via Aurelia Antica fino ai monti
del Trullo ed è delimitata storicamente ad est e
ad ovest da strade di crinale: sul proseguimento
della via Olimpica , la via del Casaletto ed a
partire dal Forte Aurelio, via di Bravetta e Via
Casetta Mattei. Trasversalmente la valle è
attraversata di via della Nocetta che costeggia
villa Panphily e da via Portuense.
Morfologicamente l'area del parco si presenta come
un altopiano ondulato che con un movimento di
collinette degrada verso il Tevere, inciso da nord
a sud dal fosso dell'Affogalasino che riceve le
acque di numerosi rigagnoli , dal fosso di S.
Passera e dal fosso di Papa Leone. Lungo gli assi
stradali citati e la via del Trullo è addensata
una intensa urbanizzazione mentre le aree interne
risultano interessate solo marginalmente da
edificazione sparsa e presentano ancora notevoli
caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.
L'area della Valle dei Casali risulta inoltre
strategica per collegare tra loro il sistema di
ville storiche del settore sud ovest della città
costituito da Villa Panphily, Villa Carpegna,
Villa Abamelek, Villa Piccolomini, Villa Flora e
Villa Bonelli realizzando un corridoio di verde
fino alle sponde del Tevere. Tra le aree che hanno
conservato intatte le caratteristiche
storico-ambientali in particolare ricordiamo la
villa York, i casali posti sulla collinetta
percorsa da vicolo Silvestri e sull'area del Buon
Pastore a nord ed al di là della via Portuense,
il complesso di Villa de Angelis ed il monte del
Trullo, limite sud estremo del parco, che si
affaccia sulla Valle del Tevere. Le peculiarità
del parco urbano della valle dei Casali è quindi
quella di un parco- campagna inserito in un
contesto urbanizzato, le cui finalità dovranno
essere la tutela, conservazione e valorizzazione
naturalistica, il recupero e valorizzazione della
villa York, del sistema dei Casali e della
Cappella di Sant'Agata nonchè la protezione,
riassetto e l'eventuale rilancio delle vocazioni
agricole.
Da un punto di vista topografico la valle si
estende per oltre 6 Km con direzione nord-sud da
Villa Panphyli e via Aurelia Antica fino ai monti
del Trullo ed è delimitata storicamente ad est e
ad ovest da strade di crinale: sul proseguimento
della via Olimpica , la via del Casaletto ed a
partire dal Forte Aurelio, via di Bravetta e Via
Casetta Mattei. Trasversalmente la valle è
attraversata di via della Nocetta che costeggia
villa Panphily e da via Portuense.
Morfologicamente l'area del parco si presenta come
un altopiano ondulato che con un movimento di
collinette degrada verso il Tevere, inciso da nord
a sud dal fosso dell'Affogalasino che riceve le
acque di numerosi rigagnoli , dal fosso di S.
Passera e dal fosso di Papa Leone. Lungo gli assi
stradali citati e la via del Trullo è addensata
una intensa urbanizzazione mentre le aree interne
risultano interessate solo marginalmente da
edificazione sparsa e presentano ancora notevoli
caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.
L'area della Valle dei Casali risulta inoltre
strategica per collegare tra loro il sistema di
ville storiche del settore sud ovest della città
costituito da Villa Panphily, Villa Carpegna,
Villa Abamelek, Villa Piccolomini, Villa Flora e
Villa Bonelli realizzando un corridoio di verde
fino alle sponde del Tevere. Tra le aree che hanno
conservato intatte le caratteristiche
storico-ambientali in particolare ricordiamo la
villa York, i casali posti sulla collinetta
percorsa da vicolo Silvestri e sull'area del Buon
Pastore a nord ed al di là della via Portuense,
il complesso di Villa de Angelis ed il monte del
Trullo, limite sud estremo del parco, che si
affaccia sulla Valle del Tevere. Le peculiarità
del parco urbano della valle dei Casali è quindi
quella di un parco- campagna inserito in un
contesto urbanizzato, le cui finalità dovranno
essere la tutela, conservazione e valorizzazione
naturalistica, il recupero e valorizzazione della
villa York, del sistema dei Casali e della
Cappella di Sant'Agata nonchè la protezione,
riassetto e l'eventuale rilancio delle vocazioni
agricole.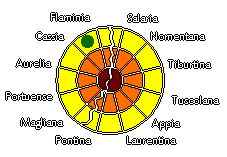 Nell'ambito dei confini del Comune di Roma esso
costituisce solo una parte (circa 6.000 ha) del più
ampio Parco di Veio previsto dal Sistema dei
Parchi e delle Riserve della Regione Lazio che
vede coinvolti oltre al Comune di Roma, i comuni
di Formello, Campagnano, Sacrofano, Morlupo e
Castelnuovo di Porto per un estensione di circa
16.000 ha . Morfologicamente il comprensorio del
parco, delimitato ad est e ad ovest dai crinali
percorsi dalle consolari, è costituito da
altipiani in tufo utilizzati a coltivazioni
agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da
fossi, il fosso della Crescenza, il fosso della
Valchetta , e quello della Torraccia, che si
immettono nel Tevere, e da pendici ricoperte da
folti boschi rimasti ancora allo stato naturale,
tutti elementi caratteristici della struttura
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La
morfologia stessa di quest'area, antropizzata fin
dai tempi della civiltà etrusca, l'ha preservata
probabilmente dalla più massiccia urbanizzazione
che ha interessato altre parti del territorio
comunale, contribuendo a conservare vaste aree di
intenso valore paesaggistico che negli ultimi anni
tuttavia sono state sempre più invase da
edificazioni sparse, lottizzazioni convenzionate o
spesso abusive, e grandi infrastrutture come
l'ospedale di S. Andrea e le costruzioni della
Telecom. L'edificazione intensiva ha interessato
soprattutto le aree a ridosso delle consolari
mentre nuclei di edilizia spontanea sono sorti
nell'area di Labaro - Prima Porta e lungo la via
Sacrofanese e via di Santa Cornelia. Gli elementi
che caratterizzano questo tratto di Agro Romano, e
ne fanno un parco dalle multiformi vocazioni sono
la sua morfologia strettamente connessa alla
storia degli insediamenti, gli aspetti
naturalistici e il suo paesaggio. L'intero settore
territoriale dove più intenso è stato l'incontro
della civiltà etrusca con quella latina, è
dominata dalla presenza della città di Veio,
dalle necropoli disposte nei pianori tufacei e
dalle sue strutture di comunicazione con Roma ed i
centri etruschi vicini, tra cui Via Cassia, la Via
Veientana, ancora riconoscibile e punteggiata da
presenze monumentali ed un asse trasversale che
congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla Domus
culta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di
grande interesse archeologico oltre all'abitato ed
alle necropoli di Veio sono alcune grandi ville di
epoca romana fra le quali Villa di Livia, la Villa
Lucio, il sepolcro dei Masoni, la Tomba dei
Veienti, il sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di
Malborghetto oltre ad altre anonime strutture
insediative poste in diverse zone del parco. Di
epoca medioevale e rinascimentale, oltre alla
vetusta domus culta Capracorum, sono gli
insediamenti di Isola Farnese, di Tor Vergara,
della Crescenza, della Storta e della Giustiniana
oltre ed una serie di strutture minori di difesa e
sfruttamento agricolo del territorio lungo le
principali direttive viarie. L'articolazione del
territorio riflette ancora il relativo
frazionamento in vigne vicino alla città ed in
grandi tenute nelle parti più periferiche a cui
fanno riferimento gli antichi casali del Fosso,
del Pino, dei Tre Archi, di Santa Cornelia, della
Vacchereccia, di Buon Ricovero, di Tor Vergara
della Spizzichina, di Ospedaletto Annunziata,
della Crescenza, di Monte Oliviero, della
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli
aspetti naturalistici sono vari e ricchissimi
rispondenti all'articolata morfologia del
territorio. Sono presenti boschi della macchia
mediterranea, soprattutto nella parte nord, boschi
legati ad ambienti più termofili dominati dalla
presenza di roverella mentre nelle condizioni più
mesofile prevalgono boschi di querceti caduciformi.
La vegetazione lungo le vie dei fossi rispecchia
le associazioni vegetali tipiche degli ambienti
umidi con presenza di pioppi, ontani e salici. Non
mancano inoltre specie rare, soprattutto nei
cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi e relitti
di antiche foreste. L'agricoltura che
rappresentava per gli etruschi insieme al
commercio il cardine dell'economia cittadina
malgrado le tante trasformazioni avvenute
attraverso i secoli ancora oggi caratterizza
fortemente il paesaggio di questo territorio.
Nell'ambito dei confini del Comune di Roma esso
costituisce solo una parte (circa 6.000 ha) del più
ampio Parco di Veio previsto dal Sistema dei
Parchi e delle Riserve della Regione Lazio che
vede coinvolti oltre al Comune di Roma, i comuni
di Formello, Campagnano, Sacrofano, Morlupo e
Castelnuovo di Porto per un estensione di circa
16.000 ha . Morfologicamente il comprensorio del
parco, delimitato ad est e ad ovest dai crinali
percorsi dalle consolari, è costituito da
altipiani in tufo utilizzati a coltivazioni
agricole, da valloni a volte scoscesi, scavati da
fossi, il fosso della Crescenza, il fosso della
Valchetta , e quello della Torraccia, che si
immettono nel Tevere, e da pendici ricoperte da
folti boschi rimasti ancora allo stato naturale,
tutti elementi caratteristici della struttura
geomorfologica dell'Etruria Meridionale. La
morfologia stessa di quest'area, antropizzata fin
dai tempi della civiltà etrusca, l'ha preservata
probabilmente dalla più massiccia urbanizzazione
che ha interessato altre parti del territorio
comunale, contribuendo a conservare vaste aree di
intenso valore paesaggistico che negli ultimi anni
tuttavia sono state sempre più invase da
edificazioni sparse, lottizzazioni convenzionate o
spesso abusive, e grandi infrastrutture come
l'ospedale di S. Andrea e le costruzioni della
Telecom. L'edificazione intensiva ha interessato
soprattutto le aree a ridosso delle consolari
mentre nuclei di edilizia spontanea sono sorti
nell'area di Labaro - Prima Porta e lungo la via
Sacrofanese e via di Santa Cornelia. Gli elementi
che caratterizzano questo tratto di Agro Romano, e
ne fanno un parco dalle multiformi vocazioni sono
la sua morfologia strettamente connessa alla
storia degli insediamenti, gli aspetti
naturalistici e il suo paesaggio. L'intero settore
territoriale dove più intenso è stato l'incontro
della civiltà etrusca con quella latina, è
dominata dalla presenza della città di Veio,
dalle necropoli disposte nei pianori tufacei e
dalle sue strutture di comunicazione con Roma ed i
centri etruschi vicini, tra cui Via Cassia, la Via
Veientana, ancora riconoscibile e punteggiata da
presenze monumentali ed un asse trasversale che
congiungeva Veio e l'Isola Farnese alla Domus
culta Capracorum presso Santa Cornelia alla Via
Flaminia e alla Valle del Tevere. Elementi di
grande interesse archeologico oltre all'abitato ed
alle necropoli di Veio sono alcune grandi ville di
epoca romana fra le quali Villa di Livia, la Villa
Lucio, il sepolcro dei Masoni, la Tomba dei
Veienti, il sepolcro di Vibio Mariano, l'arco di
Malborghetto oltre ad altre anonime strutture
insediative poste in diverse zone del parco. Di
epoca medioevale e rinascimentale, oltre alla
vetusta domus culta Capracorum, sono gli
insediamenti di Isola Farnese, di Tor Vergara,
della Crescenza, della Storta e della Giustiniana
oltre ed una serie di strutture minori di difesa e
sfruttamento agricolo del territorio lungo le
principali direttive viarie. L'articolazione del
territorio riflette ancora il relativo
frazionamento in vigne vicino alla città ed in
grandi tenute nelle parti più periferiche a cui
fanno riferimento gli antichi casali del Fosso,
del Pino, dei Tre Archi, di Santa Cornelia, della
Vacchereccia, di Buon Ricovero, di Tor Vergara
della Spizzichina, di Ospedaletto Annunziata,
della Crescenza, di Monte Oliviero, della
Valchetta, di Prima Porta e di Malborghetto. Gli
aspetti naturalistici sono vari e ricchissimi
rispondenti all'articolata morfologia del
territorio. Sono presenti boschi della macchia
mediterranea, soprattutto nella parte nord, boschi
legati ad ambienti più termofili dominati dalla
presenza di roverella mentre nelle condizioni più
mesofile prevalgono boschi di querceti caduciformi.
La vegetazione lungo le vie dei fossi rispecchia
le associazioni vegetali tipiche degli ambienti
umidi con presenza di pioppi, ontani e salici. Non
mancano inoltre specie rare, soprattutto nei
cunicoli tufacei scavati dagli Etruschi e relitti
di antiche foreste. L'agricoltura che
rappresentava per gli etruschi insieme al
commercio il cardine dell'economia cittadina
malgrado le tante trasformazioni avvenute
attraverso i secoli ancora oggi caratterizza
fortemente il paesaggio di questo territorio.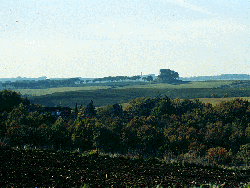 Presenti boschi con dominanza di roverella (Quercus
pubescens) in ambienti più termofili. In
condizioni più mesofile prevalgono boschi misti
di querceti caducifoglie a cerro (Quercus cerris)
farnia (Quercus robur), acero (Acer campestre).
Presenti boschi misti a cerro (Quercus cerris),
carpino (Carpinus betulus) e castagno (Castanea
sativa). Particolarmente estese le siepi a
prugnolo (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus
monogyna), le siepi a corniolo (Cornus sanguinea)
ed a rovo (Rubus ulmifolius); è presente la
ginestra (Spartium junceum); quest' ultima si
estende anche in formazioni monofitiche su
prati-pascoli su substrato tufaceo. La vegetazione
erbacea delle aree a prato e prato-pascolo ha
subito la selezione dovuta all'uso del suolo. La
vegetazione igrofila dei bacini idrografici e
delle rive dei fossi rispecchia le associazioni
vegetali tipiche con presenza di pioppi, ontani,
salici,olmi, sambuchi. Di notevole entità è la
distribuzione di felci di cui sono state
riscontrate forme arcaiche relitte. Da segnalare
relitti delle antiche foreste "Moesia"
ed "Arsia", di epoca etrusco-romana con
elementi mesofili come Quercus robur, Carpinus
betulus, Corylus avellana. Peculiari anche da un
punto di vista floristico le stazioni botaniche
presenti nelle gallerie e nei cunicoli tufacei
scavati dagli Etruschi con specie rare tra le
quali: Gymnogramme Leptophyila , Carex remota,
Phytilis scolopendrium, Cardamine amara segnalate
dalla Commmissione Straordinaria istituita dalla
Regione Lazio per lo studio dei biotopi da
proteggere nel Lazio. Nelle aree periurbane ed ai
margini dei campi sono presenti nuclei di falsa
acacia (Robinia pseudacacia) mentre le aree
adiacenti l'urbanizzato e i grandi viali di
accesso ai casali ed alle ville sono
caratterizzate da essenze di impianto artificiale
introdotte in tempi più o meno recenti costituiti
principalmente da pini , eucalitti, cedri ,
oleandri.
Presenti boschi con dominanza di roverella (Quercus
pubescens) in ambienti più termofili. In
condizioni più mesofile prevalgono boschi misti
di querceti caducifoglie a cerro (Quercus cerris)
farnia (Quercus robur), acero (Acer campestre).
Presenti boschi misti a cerro (Quercus cerris),
carpino (Carpinus betulus) e castagno (Castanea
sativa). Particolarmente estese le siepi a
prugnolo (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus
monogyna), le siepi a corniolo (Cornus sanguinea)
ed a rovo (Rubus ulmifolius); è presente la
ginestra (Spartium junceum); quest' ultima si
estende anche in formazioni monofitiche su
prati-pascoli su substrato tufaceo. La vegetazione
erbacea delle aree a prato e prato-pascolo ha
subito la selezione dovuta all'uso del suolo. La
vegetazione igrofila dei bacini idrografici e
delle rive dei fossi rispecchia le associazioni
vegetali tipiche con presenza di pioppi, ontani,
salici,olmi, sambuchi. Di notevole entità è la
distribuzione di felci di cui sono state
riscontrate forme arcaiche relitte. Da segnalare
relitti delle antiche foreste "Moesia"
ed "Arsia", di epoca etrusco-romana con
elementi mesofili come Quercus robur, Carpinus
betulus, Corylus avellana. Peculiari anche da un
punto di vista floristico le stazioni botaniche
presenti nelle gallerie e nei cunicoli tufacei
scavati dagli Etruschi con specie rare tra le
quali: Gymnogramme Leptophyila , Carex remota,
Phytilis scolopendrium, Cardamine amara segnalate
dalla Commmissione Straordinaria istituita dalla
Regione Lazio per lo studio dei biotopi da
proteggere nel Lazio. Nelle aree periurbane ed ai
margini dei campi sono presenti nuclei di falsa
acacia (Robinia pseudacacia) mentre le aree
adiacenti l'urbanizzato e i grandi viali di
accesso ai casali ed alle ville sono
caratterizzate da essenze di impianto artificiale
introdotte in tempi più o meno recenti costituiti
principalmente da pini , eucalitti, cedri ,
oleandri. L'area consta di un gruppo di alture delimitate ad
est dall'ampia pianura alluvionale del Tevere,
caratterizzata da brevi diramazioni del crinale
principale su cui scorre la via Nomentana.
L'area consta di un gruppo di alture delimitate ad
est dall'ampia pianura alluvionale del Tevere,
caratterizzata da brevi diramazioni del crinale
principale su cui scorre la via Nomentana.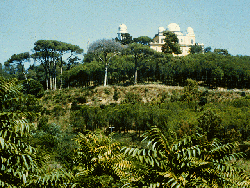 Esso è delimitato a nord da Via dei Colli della
Farnesina, ad est dalla Via Olimpica, a sud da
Piazzale Clodio, Via Trionfale, Circonvallazione
Trionfale e ad est in successione da Via Fedro,
Via Cadlolo, Via Tionfale e Via della Camilluccia.
In base all'art. 2 della legge regionale del 17
luglio 1989 n.46, che inseriva la realizzazione
del Parco di Monte Mario ed il recupero di Villa
Mazzanti tra i programmi per i Mondiali di Calcio
del 1990 con l'intenzione di realizzare un'opera
che, oltre alla funzione di verde pubblico
fruibile, avesse le valenze di compensazione
ambientale per il settore urbano che maggiormente
avrebbe subito l'impatto delle opere per i
mondiali, sono già stati attuati gran parte degli
interventi previsti da un progetto esecutivo che
interessava prevalentemente le aree di proprietà
pubblica ed aree di cui si proponeva
l'acquisizione o la cessione, e riguardavano la
vegetazione, le opere di regimazione delle acque
superficiali ed il mantenimento dei pendii, la
realizzazione dei percorsi e di aree attrezzate.
Esso è delimitato a nord da Via dei Colli della
Farnesina, ad est dalla Via Olimpica, a sud da
Piazzale Clodio, Via Trionfale, Circonvallazione
Trionfale e ad est in successione da Via Fedro,
Via Cadlolo, Via Tionfale e Via della Camilluccia.
In base all'art. 2 della legge regionale del 17
luglio 1989 n.46, che inseriva la realizzazione
del Parco di Monte Mario ed il recupero di Villa
Mazzanti tra i programmi per i Mondiali di Calcio
del 1990 con l'intenzione di realizzare un'opera
che, oltre alla funzione di verde pubblico
fruibile, avesse le valenze di compensazione
ambientale per il settore urbano che maggiormente
avrebbe subito l'impatto delle opere per i
mondiali, sono già stati attuati gran parte degli
interventi previsti da un progetto esecutivo che
interessava prevalentemente le aree di proprietà
pubblica ed aree di cui si proponeva
l'acquisizione o la cessione, e riguardavano la
vegetazione, le opere di regimazione delle acque
superficiali ed il mantenimento dei pendii, la
realizzazione dei percorsi e di aree attrezzate. In particolare il parco della Valle dell'Aniene si
estende lungo il corso dell'Aniene, attingendo
"aree libere" in riva destra ed in riva
sinistra; ampliamenti di questo parco
"lineare" si riscontrano in
corrispondenza del Parco di Tor Sapienza,
dell'area di protezione delle falde idriche
dell'Acquedotto dell'Acqua Vegine e dell'intera
area occupata dall'antico lago di Castiglione fino
a San Vittorino.
In particolare il parco della Valle dell'Aniene si
estende lungo il corso dell'Aniene, attingendo
"aree libere" in riva destra ed in riva
sinistra; ampliamenti di questo parco
"lineare" si riscontrano in
corrispondenza del Parco di Tor Sapienza,
dell'area di protezione delle falde idriche
dell'Acquedotto dell'Acqua Vegine e dell'intera
area occupata dall'antico lago di Castiglione fino
a San Vittorino.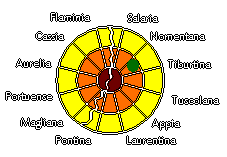 Per quanto riguarda l'attuale aspetto morfologico
del territorio, esso è il risultato della
combinazione ed interazione di tali fattori, quali
gli agenti degradatori naturali e di origine
antropica, le caratteristiche geologiche e il
clima.
Per quanto riguarda l'attuale aspetto morfologico
del territorio, esso è il risultato della
combinazione ed interazione di tali fattori, quali
gli agenti degradatori naturali e di origine
antropica, le caratteristiche geologiche e il
clima.