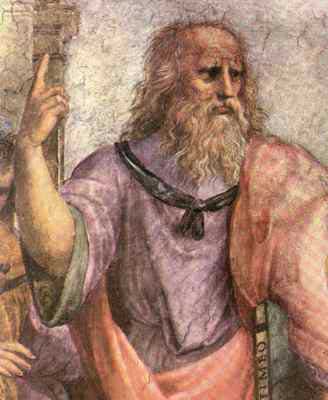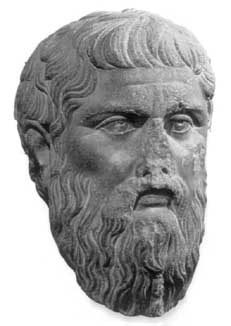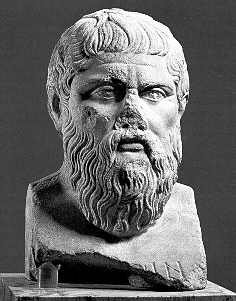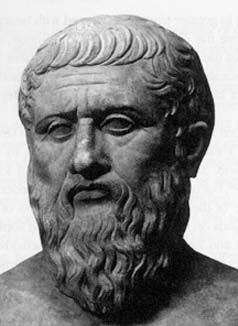"Atlantis.
Indagine
bibliografica dalle fonti di Platone fino agli scrittori moderni e le
ipotetiche ricostruzioni cartografiche"
"Atlantis.
Indagine
bibliografica dalle fonti di Platone fino agli scrittori moderni e le
ipotetiche ricostruzioni cartografiche"
a cura di
Ernesto Paleani..

Filosofo
greco (Atene 428/427-347 a.C.). Nato
da famiglia aristocratica,
discendente per parte di madre da Solone, sin da giovane ebbe una
educazione filosofica; secondo Aristotele conobbe Cratilo, scolaro
di Eraclito, e si familiarizzò con la dottrina eraclitea. Ma in
questo primo periodo la sua attività fu rivolta a composizioni
letterarie, epiche e tragiche. A vent'anni conobbe Socrate, che lo
guidò a un contatto fecondo con la filosofia.
Dopo la morte di Socrate Platone
intraprese svariati viaggi, di cui uno forse in Egitto.
Significativi per il rapporto con la politica sono i tre viaggi in
Magna Grecia. A Siracusa, dove si legò di amicizia con Dione, zio
di Dionisio il Giovane, Platone tentò di attuare la sua idea del
governante illuminato dal filosofo. Ma Dionisio il Vecchio, allora
tiranno della città, preoccupato dei suoi progetti, lo fece
allontanare.
Fu
al ritorno ad Atene che costituì l'Accademia, società culturale,
alla quale diede la struttura di un'associazione religiosa. Quando
Dionisio il Giovane succedette al padre,egli tornò a Siracusa
per riprendere il suo progetto, ma Dionisio, dilettante-presuntuoso
del potere, lo deluse tanto che se ne tornò ad Atene. Una terza
volta egli tornò a Siracusa, ma ancora fallì il suo tentativo di
instaurare un governo retto dalla filosofia. Denso di polemiche è
stato fin dall'antichità il processo della storiografia filosofica
per stabilire l'autenticità degli scritti di Platone. La grandezza
della sua personalità, che ha costituito il punto di riferimento di
una lunga tradizione, ha fatto sì che gli fossero attribuite molte
opere da lui non scritte. Il rigore della filologia ottocentesca ha
esasperato il problema, finendo col considerare spurie la maggior
parte delle opere. In seguito la critica moderna, tenendo maggior
conto della tradizione, ha preferito operare con più cautela;
servendosi delle testimonianze antiche, considerando il contenuto
dottrinale e soprattutto fondandosi sulla forma linguistica, ha
riaccolto come autentici parecchi dialoghi. Importante è pure il
problema della cronologia degli scritti, se si considera l'asistematicità
del suo pensiero , per cui ritrovare la successione dei dialoghi
significa cogliere lo sviluppo del suo stesso pensiero. I
dialoghi vengono ordinati in base a vari criteri stilistici e di
contenuto e raggruppati come segue: I periodo, scritti giovanili
socratici, Apologia di Socrate, Critone, Ione, Alcibiade
I, Lachete, Liside, Carmide, Eutifrone;
II periodo, di trapasso, Eutidemo, Ippia Minore,
Cratilo, Ippia Maggiore, Menesseno, Gorgia, Repubblica
I, Protagora, Menone; III periodo, dottrina delle idee,
Fedone, Convito, Repubblica II-X, Fedro; IV periodo,
autocritica e fase finale, Parmenide, Teeteto, Sofista,
Politico, Filebo, Timeo, Crizia, Le leggi.A questi dialoghi
vanno aggiunte 13 Lettere, di cui la VII e l'VIII sono in
genere date per autentiche. Il carattere dialogico degli scritti di
Platone rappresenta la sostanza stessa della sua filosofia. Il
dialogo platonico è sempre costituito da una tesi aperta, che nel
contraddittorio viene esplicandosi, mentre
l'interlocutore-contraddittore sposta di continuo le sue opposizioni
di volta in volta che una verità va affermandosi. È lui stesso
adeguatamente sollecitato a riconoscere la verità. Notevole è il
cambiamento di stile da un dialogo all'altro: i dialoghi giovanili
sono caratterizzati da interventi brevi e vivaci da parte dei
partecipanti e conservano intatta la loro natura dialogica; gli
ultimi sono appesantiti da lunghi interventi, che svisano
l'andamento del dialogo e ne fanno quasi un trattato. Socrate è
quasi sempre il protagonista, ma negli ultimi dialoghi la sua figura
è sempre più sfocata o addirittura scompare.
|

|